"Cut to Commercial…": Intervista a Tony Carnevale

Colonne Sonore: Tony, dopo la specializzazione in direzione di coro ti sei diviso tra progressive, discografia e rock sinfonico, mantenendoti sempre in contatto con la musica applicata: in fatto di linguaggi hai sperimentato praticamente tutto. Come spieghi questo impressionante eclettismo?
Tony Carnevale: Devo puntualizzare che in realtà gli studi sono arrivati dopo. Sono partito suonando una fisarmonica regalatami da mio zio quando avevo otto anni: talmente grande che non riuscivo neanche a suonarla in piedi - una fatica immensa! Sono andato avanti tantissimo tempo come autodidatta: quando sono entrato in conservatorio avevo 18 anni. Ma avevo già fatto un disco come arrangiatore e un centinaio di concerti, anche con pezzi miei; un’attività molto intensa, anche dal punto di vista della pratica, non soltanto legata alle giornate passate in cantina a suonare ma anche a livello di esibizioni pubbliche. Ed erano momenti particolari quelli, c’era un gran fermento musicale. Sono praticamente cresciuto con tutto quello che poi è diventato il prog come genere: Genesis, Yes, Emerson Lake & Palmer, il Banco. Tutto questo contemporaneamente alla grande fioritura del movimento jazzistico, che iniziava a svilupparsi in Italia. Tutte cose di grande livello. In mezzo c’era poi quella parte “estiva”, le canzoni di Battisti e Baglioni, che per quanto vuoi - anche se uno i dischi non li ha mai comprati - si sono comunque legate alle storie della vita, ai primi amori. Ascoltavo anche un certo country americano: Bob Dylan, Cat Stevens. E poi mi andavo a cercare sull’organetto le note di una toccata di Bach. Non ho mai diviso per stili, e ancora oggi non lo faccio; se una cosa è bella è bella, non sto a guardare se è pop, se è rock…non mi interessa. Basta che ci sia un’emozione, un’intenzione comunicativa che arrivi. Forse proprio grazie a questa grande curiosità sono venuto su ascoltando e suonando un po’ di tutto, e incontrando personaggi particolarissimi, molti dei quali sono oggi tra i musicisti più affermati.
Entrando in conservatorio ho cominciato ad approfondire, chiaramente anche raffinandomi. Ho studiato pianoforte, composizione e ho frequentato anche il corso di musica elettronica. Alla fine, quindi, la direzione di coro è stato un approfondimento. Mi interessava lavorare con le voci ed è una cosa che mi ha sempre aiutato nei lavori come vocal-trainer per gli interpreti nelle direzioni artistiche.
CS: Che tipo di ambiente hai trovato all’interno del conservatorio, a livello accademico?
TC: Orrendo. Il conservatorio è un posto terribile, secondo me dove meno si parla di musica. Un mondo chiuso su se stesso, vecchio, stantio, che tende a uniformare – perché ti impedisce ogni originalità. Credo che la cosa si riassuma in unico aspetto: il conservatorio oggi può essere utile, e nemmeno tantissimo, ad uno che voglia fare lo strumentista d’orchestra o il solista di musica classica, al limite il direttore d’orchestra. Chi vuole suonare e vivere di musica deve lasciar perdere l’idea che al conservatorio possa venir fuori con qualcosa in mano, perché al più si ritrova con un diploma e poi si ammazzerà a fare dei concorsi per insegnante alle scuole medie.
CS: Sei entrato in contatto con la musica applicata già durante gli sutdi?
TC: Si. Avevo cominciato a lavorare con la televisione, agli inizi di Canale 5, facendo piccole cose come sonorizzazione e precedentemente avevo già lavorato per il teatro. Diciamo che la musica applicata si era già fatta viva. Poi con la televisione è completamente esplosa, quando intorno all’85 ho cominciato a lavorare in maniera intensissima.
CS: Entriamo nel dettaglio di questo trascorso televisivo.
TC: Dunque ho iniziato facendo appunto cose abbastanza semplici come le sonorizzazioni, mi ricordo delle parodie per una cosa natalizia, stupidaggini… Avevo un sintetizzatore e un registratore a quattro piste. Poi a un certo punto hanno cominciato ad affidarmi delle produzioni vere e proprie, una si chiamava Festival, con Baudo; all’interno c’erano delle gags di Gaspare e Zuzzurro. Ne avrò fatte tantissime. Erano delle parodie di pubblicità famose e dovevo occuparmi di tutto quello che era suono, quindi non soltanto della musica ma anche di tutti gli effetti. Suonavo direttamente sopra le immagini, poi andavo a correggere. Detta così sembra una grande banalità, ma è un’esperienza che mi sono ritrovato nel tempo; anni dopo, quando mi sarebbe tornata utile l’abitudine a lavorare velocemente, ad avere una particolare immediatezza rispetto alle immagini. In particolare quando lavorai con Maria Teresa Dal Medico e Renato Greco, feci un esperimento su una coreografia bellissima di cui però la musica non mi piaceva. Ho preso questo video, ho tolto l’audio, e guardando le immagini ho rifatto una musica completamente nuova a sincrono con le immagini. Quando l’hanno visto sono impazziti, perché sembravano bravissimi nella lettura della musica. La cosa era stata fatta in realtà al contrario perché ero io che seguivo i loro movimenti. E ho cominciato a fare questi lavori stranissimi, cioè a musicare movimenti già esistenti, diversamente da quanto si fa normalmente nella danza. Anche all’estero: ad esempio uno spettacolo fatto a Manhattan per il mondo sportivo-culturale-scientifico a fine di beneficenza (mi diedero un nastro che sarebbe dovuto partire la mattina seguente!). E’ diventata la mia caratteristica, riuscire ad entrare nei tempi di un filmato già montato e lo devo all’allenamento fatto su quelle centinaia di gags con Gaspare e Zuzzurro. Un’esperienza che poi ti aiuta a piegare la musica, a gestire il tempo in maniera musicale.
CS: Questa sorta di impatto emotivo immediato è quindi diventato il tuo modus operandi…
TC: Io preferisco in assoluto lavorare sulle immagini. Sempre. Quando in pubblicità mi danno lo storyboard o al cinema la sceneggiatura proprio non mi basta, perché come hai detto io devo acchiappare l’emozione della scena, che non sempre sulla carta si può comprendere. Salvo alcuni casi - per esempio mi è capitato di dover fornire dei brani prima dell’inizio delle riprese - lavoro sempre sul montaggio definitivo o perlomeno su quello più prossimo. Non amo rimetterci le mani; mi rifaccio molto al tempo, non solo a quello fisico ma anche al ritmo interno delle immagini. Per me quello che conta è appunto vedere e respirare quella che può essere l’atmosfera.
CS: Come sei approdato alla pubblicità?
TC: In un modo curiosissimo. Una mattina, forse preso da chissà quale strana idea, sono andato alla SBP, una delle prime grandi strutture che faceva montaggi video a Roma. Non conoscevo nessuno. In segreteria chiedo di parlare con un direttore e mi ritrovo in una stanza con un direttore creativo e due dirigenti della RAI che stavano approvando la sigla della Anicagis (Appuntamento al cinema). Mi dicono: “Ah, tu sei un musicista…vieni che abbiamo bisogno di te”. “Per caso avresti una proposta da fare?”. Sono partito di corsa e dopo tre ore ero lì con due proposte finite. Era il 1986 e quella sigla va ancora in onda. E va considerata uno spot a tutti gli effetti. In quel momento ero uno dei pionieri nell’utilizzo delle tecnologie in musica e potevo offrire dei risultati molto alti da un punto di vista realizzativo con spese alle quali loro non erano abituati. Quindi ho cominciato a farne una dopo l’altra e a presentarmi ad agenzie molto importanti. E c’è stato un periodo in cui andavo molto di moda (ride). In Italia ho lavorato per tante marche - molte anche all’estero - per le convention di settore, per i filmati industriali a circolazione interna… Una montagna di cose. Mi ci sono ritrovato in maniera assolutamente casuale. Un mondo divertentissimo. In più ero molto giovane e quindi erano tutti molto più invogliati.
CS: Come eri solito lavorare ad uno spot?
TC: All’inizio, purtroppo, sempre con gli storyboard. A volte, quando disperatamente glielo chiedevo, si faceva il “rubamatic”, cioè un animatic fatto rubando scene da altri spot. La difficoltà però, quasi sempre, è che loro ti danno un briefing, che, ahimè, spesso è sbagliato. Anche lì funziona con le mode. Si passa dalla musica bandistica alle parodie. A seconda del momento. Quando andava bene avevi il filmato finale, cosa che per me, per il mio modo di lavorare, era di gran lunga migliore.
Di solito il referente è il copyrighter, o il cosiddetto creativo. Sono loro che hanno l’idea e che quindi ti danno indicazioni anche sulla musica. Il problema, come dicevo, è che spesso erano delle cose terribili, infatti di solito preferivo presentare due proposte differenti, una personale l’altra secondo briefing. Tant’è che spesso passava la prima. Oggi in pubblicità funziona prevalentemente a livello di eventi discografici. C’è un accordo tra le case discografiche e le agenzie - per utilizzare il pezzo di maggior richiamo – usando lo spot anche come vetrina musicale. Poi sono cominciate ad apparire società specializzate nelle musiche già pronte, come la Flipper Music. La tendenza è stata quindi quella di abbassare sempre più il budget per le musiche. Io sono comunque rimasto dell’opinione che una pubblicità che funziona ha la “sua” musica.
CS: Quale libertà avevi nella scelta della strumentazione, a livello di esecuzione?
TC: A parte qualche raro caso in cui ho usato strumenti solisti, come sassofono o chitarra - gli unici due strumenti che non si riesce a riprodurre bene - se non ricordo male, io non ho mai usato strumenti veri in pubblicità. Se ne avessi comunque avuto bisogno, forse i primi tempi, quando c’erano dei budget veri, ne avrei potuto usufruire. CS: Passando al cinema, come sei arrivato alla colonna sonora di Una Bellezza Che Non Lascia Scampo ?
CS: Passando al cinema, come sei arrivato alla colonna sonora di Una Bellezza Che Non Lascia Scampo ?
TC: Al film sono arrivato in un modo molto particolare. Sappiamo bene qual è la situazione del nostro cinema; purtroppo ci sono delle situazioni blindate, è difficilissimo fare una colonna sonora in Italia. Io ho avuto la fortuna di conoscere questa regista, Francesca Pirani, per semplici questioni di rapporti umani. Non avevamo mai lavorato insieme prima né credo lei avesse mai sentito cose mie. Ci frequentavamo come tanti senza avere un rapporto diretto. Lei però si è basata sulla conoscenza della persona e quando mi ha proposto il film mi ha detto: “Secondo me sei adatto per fare questa pellicola”. Alla fine insomma era deciso che sarei stato il musicista del suo film, senza che lei avesse mai sentito nulla di mio. All’inizio è stato un rapporto molto difficile. Lei aveva delle idee molto precise riguardo al film e alle musiche, tanto da aver già scelto dei brani noti da inserire. Cosa alla quale io mi sono opposto. Le ho detto che avrei composto tutto o niente, magari adattandomi allo stile di quei particolari brani (come accade infatti nel finale dove c’è un quartetto d’archi che prende appunto spunto dall’Opera 132 di Beethoven, la sua prima scelta).
CS: Quindi una sorta di temp-tracking basato sul repertorio classico…
TC: No, in realtà lei ha fatto un’altra cosa: girando il film, per far respirare certe atmosfere, metteva questa musica sul set. Io non c’ero, ma mi sarei opposto. Sono contrarissimo ad appoggiare qualunque tipo di musica su un film se non è quella che deve effettivamente starci. Perché succedono delle cose incredibili. Molto spesso i montatori appoggiano Beethoven e Šostakoviè! (ride), oppure Vangelis e Morricone. Ma allora andateli a chiamare! Anche perché io, per quanto sconosciuto rispetto a questi nomi, ho una mia dignità. Io la musica la so fare, poi può piacere o non piacere, ma ognuno ha il suo modo. Il problema è che poi uno si abitua a quelle musiche e comincia a rimpiangere l’appoggio. Ho cominciato a fare delle proposte e su alcune cose non ci prendevamo. Ad un certo punto ho dovuto difendere le mie proposte e le mie convinzioni, non tanto da lei quanto da altri personaggi come appunto la montatrice e l’aiuto regista, che intervenivano secondo me in maniera assolutamente inopportuna. Alla fine siamo arrivati ad un idillio totale. Questo perché – confronto oggi, confronto domani – si rendeva conto che il mio intento non era quello di prevaricare le sue idee ma anzi quello di mettermi nella condizione di tirar fuori dal film le cose che dal film stesso emergevano: cercare di fare la musica del film. Alla fine è rimasta molto soddisfatta. Diverse persone che hanno visto il film sono poi venute a complimentarsi per il lavoro che abbiamo fatto sulle musiche. Insomma una situazione difficile che partiva, dopotutto, da un film molto difficile.
CS: Da quale principio sei partito per associarti, per l’appunto, a delle immagini così difficili?
TC: Io ho seguito molto da vicino il rapporto uomo/donna, cioè il rapporto tra i due protagonisti, cercando di tirar fuori l’emozione di questi due personaggi; l’evoluzione di questa musicista attraverso l’incontro con quest’uomo che suscita in lei un’attrazione e un interesse capace di trasformare anche le sue possibilità creative. Una scena particolarmente impegnativa è stata quella in cui lei lo ascolta suonare un pezzo che poi si avvia liberamente all’improvvisazione. Una scena che io naturalmente ho affrontato per la prima volta senza musica, sebbene loro avessero usato un quartetto di Beethoven durante le riprese. Alla fine però mi sembra che la cosa sia riuscita e quello credo sia l’unico passaggio riconducibile ad un tema, quelle note che riappaiono anche nel finale, completamente trasformate. Dopotutto tra i due personaggi c’è stata proprio una trasformazione ed è anche per questo che non mi piaceva il fatto che ci fosse un tema ricorrente. Tutto era mutevole.
CS: Sia nel film che nei tuoi lavori personali si nota una particolare predilezione per le tessiture d’archi. Come la spieghi ?
TC: Riferito al film, perché sapevo che alla regista piaceva molto l’idea di usare gli archi. Sempre mantenendo però questa situazione molto intima. Alcune scene poi sono musicate soltanto con degli armonici, soprattutto nella prima parte dove ho voluto rendere un disagio interno, giocando costantemente su questo urto di seconda, questi due violini a distanza di un tono o di un semitono, che non fanno nessuna melodia. In generale gli archi, secondo me, rappresentano una possibilità per il compositore sempre molto forte dal punto di vista espressivo, un po’ per la loro storicizzazione, un po’ perché sono strumenti con cui si può fare veramente di tutto. Nei miei lavori personali invece il discorso degli archi si spiega con il fatto che ho sempre avuto una mentalità sinfonica. Sono anche un adoratore dell’oboe, che spesso associo ad una voce femminile.
CS: A proposito di sinfonica, tu hai dimostrato grande passione per la classica entrando in un simile ambito anche a livello sperimentale, in particolare con le rivisitazioni di "Quadri di una esposizione di Musorgskij" e "L’arte della fuga di Bach", con la quale hai realizzato un lavoro in quadrifonia per la Biennale di Venezia…
TC: In quest’ultimo caso si trattava di fare la colonna sonora per un filmato a proiezione circolare, immagini ruotanti che venivano proiettate su una parete, praticamente “camminando”. Impiegavano circa 7 minuti a fare un giro completo. Quindi partivo dal presupposto di realizzare qualcosa di 7 minuti a ciclo continuo. Le immagini erano tutte riferite all’arte barocca, molto composte. Così ho preso "L’arte della fuga" e ho costruito una delle fughe che Bach avrebbe potuto scrivere ma che non ha realizzato, prendendo elementi da varie fughe e ricomponendoli in modo da formare una fuga senza soluzione di continuità, a ciclo continuo. Tant’è che la SIAE me l’ha riconosciuta come opera semi-originale, firmata Bach-Carnevale. Perché la fuga? Perché ho pensato di realizzarla in quadrifonia e mi sono scelto come struttura la fuga a quattro parti, creando un movimento nello spazio: partiva un soggetto da un altoparlante e cominciava a muoversi verso il secondo diffusore; in concomitanza con questo entrava il controsoggetto sul primo altoparlante. E così via. Senza automazione: pensa che problemi di missaggio!! E devo dire che l’effetto era davvero bello: una percezione della musica anche come movimento nello spazio. Tra l’altro poi sulla scia di questo esperimento feci un’altra cosa in quadrifonia che fu allestita a Roma, a Piazza Navona, verso gli inizi degli anni ’90, per un riunione del Consiglio Europeo: ho costruito dei brani con dei frammenti dei 12 inni nazionali dei paesi della allora Comunità Europea. Scene incredibili: gruppi di stranieri che quando arrivava il loro inno iniziavano a cantare! Molto coinvolgente. Il tutto confluiva poi nella "Nona Sinfonia" di Beethoven – l’inno Europeo- e anche in quel caso la SIAE mi riconobbe la semi-originalità del pezzo.
CS: Tra le molte esperienze audiovisive non poteva mancare quella nel cortometraggio. Mi riferisco in particolare a A un millimetro dal cuore, di Iole Natoli. Come è nata questa colonna sonora?
TC: Conoscevo la regista, la quale inizialmente mi aveva proposto una sceneggiatura che poi ha subito diverse modifiche. Alla fine ho realizzato un brano per arpa e percussione. Bisognava far capire dal modo di suonare della protagonista, per l’appunto un’arpista, che si era innamorata. Abbiamo risolto pensando di far partire involontariamente una traccia con delle percussioni durante una sua registrazione in studio: il fatto che lei non si fermi ma continui a suonare adattandosi al nuovo ritmo sta a rappresentare la sua accettazione di questa nuova situazione personale, in modo del tutto naturale. Dopodiché è stato girato il film; e io sono stato sempre presente sul set a differenza di Una bellezza che non lascia scampo. Un’altra sfida era quella di dover sincronizzare una musica che lasciasse intendere lo scorrere del tempo in un solo luogo – una discoteca – senza che la sequenza fosse stata metronomizzata in fase di ripresa, riferendomi soltanto al movimento delle persone. Per questo cortometraggio, inoltre, mi è di nuovo tornata utile la capacità di improvvisazione per una scena che prevedeva la lettura di una lettera; un dialogo tra la musica e la voce fuori campo che recita ciò che l’attore sta scrivendo.
CS: Hai dei riferimenti particolari in fatto di compositori cinematografici, in Italia e all’estero?
TC: Sinceramente non ho punti di riferimento. Ci sono delle cose che mi piacciono, ma a prescindere dagli autori. Penso molto bene ad esempio di una colonna sonora come C’era una volta in America e, mi piace un po’ meno quella de La leggenda del pianista sull’oceano – per parlare di Morricone. Mi pare ad esempio che ci sia un abisso tra il James Horner di Braveheart e quello di Titanic: il primo è un capolavoro, il secondo tutt’altro. In assoluto, anche in termini di realizzazione, di suoni. Nel mio caricatore in macchina c’è sempre il cd di Braveheart, che uso anche a scopo didattico. Nel mio immaginario ha anche superato John Williams, al quale penso soprattutto come un grandissimo orchestratore che però non mi esalta molto a livello di invenzione. Preferisco ad esempio le semplici note di una colonna sonora come quella di Betty Blue, che per me hanno dentro un mondo – come la carica emotiva nella nota di pianoforte di Eyes Wide Shut. Poi potrei citarti delle cose che qui e là ho trovato molto geniali, come nel primo Predator le percussioni che individuano l’atmosfera del predatore misterioso: una trovata di Alan Silvestri che si identifica molto più nel suono che nel tema e che a me ha sempre colpito moltissimo. Se poi vogliamo intendere il musical come colonna sonora, allora per me Jesus Christ Superstar è una gran colonna sonora.
CS: Di recente uno dei tuoi interessi principali è stato quello di convogliare questa poliedrica esperienza musicale nell’insegnamento…
TC: Si, anche se non riesco a chiamarlo insegnamento. In realtà stimolo e guido delle persone che hanno meno esperienza di me e che hanno necessità di essere in qualche maniera aiutate a risolvere dei problemi che non sono soltanto di realizzazione ma anche di ideazione. Al contrario di quanto si pensa generalmente, io credo che la creatività non sia solo un dono naturale ma che si possa anche sviluppare. Ed ho avuto delle dimostrazioni pratiche che questa cosa è verissima. E’ proprio per questo motivo che ho chiamato il mio laboratorio “Formazione e Sviluppo del Pensiero Musicale” . Invece di spiegare a delle persone soltanto quelle che possono essere delle tecniche o delle realtà professionali, io li metto nella condizione di realizzare i loro progetti in un ambiente creativo particolarissimo che è dato dalla situazione collettiva: ognuno di loro realizza un proprio progetto ma, contemporaneamente, partecipa ai progetti di tutti gli altri. Tutti i progetti vengono discussi insieme. Cerco di stimolare molto più la capacità di inventare e non la tecnica, che poi è sempre uguale e quindi produce sempre lo stesso effetto. Inoltre non è in grado di superare delle difficoltà quando le situazioni sono diverse e non corrispondono al problema per cui hai acquisto quella determinata tecnica. Bisogna a mio parere favorire lo sviluppo di un meccanismo che porti ad una soluzione non tecnica ma artistica, creativa. La composizione è fatta di vari passaggi (dalla pre-produzione in poi). Personalmente cerco di lavorare la musica come un film, come un insieme di scene. E un film può cambiare molto a secondo di come è stato montato. La composizione finisce al missaggio, come un film non si esaurisce alla sceneggiatura o alle riprese ma al montaggio. Vanno quindi riconsiderate anche delle figure professionali che bisogna imparare a mettere in relazione. Quella che io formo è una professione strana che potrebbe essere definita regista del progetto musicale. Ultimamente il corso è stato ampliato ed abbiamo aggiunto delle nuove figure: l’interprete e l’uditore, cioè un ascoltatore vero e proprio. Questo per chiudere il cerchio: chi pensa la musica, chi la esegue, chi la produce e chi l’ascolta; tutto in un unico collettivo. Vorrei sottolineare a proposito di questo progetto il sostengo che ci da l’IMAIE, l’Istituto per la tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori, perché è grazie a loro che sono riuscito a realizzare tutto questo e ad affrontare i costi di una simile operazione. Inoltre è importantissimo sottolineare che abbiamo anche il prestigioso patrocinio della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
CS: Sei appena uscito con un nuovo disco, Piano. Di cosa si tratta?
TC: Per me questo disco ha un’importanza particolare, più a livello personale che come musicista. E’ come se fossi andato a recuperare tutta una serie di cose che prima erano frammentate, diversi momenti della vita, trovando un filo che li lega tutti. Quale sia questo filo è impossibile dirlo; alla fine però l’unica cosa che teneva insieme queste musiche era l’emozione. Avevano tutte quante un carattere intimo, molto romantico, molto vicino a delle storie d’amore – molto al di là di un’intenzione di esibire un pianismo tecnico: infatti si chiama “Piano” più come un’intenzione che come “pianoforte”. Ed è stata una mia reazione all’accorgermi che in tutti questi anni ho spesso prodotto musica anche influenzato da quelle che erano le esigenze degli altri, da quello che gli altri volevano che io facessi: uscire da questa trappola del prog, dei tempi dispari, della musica che esibisce i muscoli. Io mi penso oramai molto più un comunicatore di emozioni che un musicista. E’ il mio primo vero tentativo di fare un disco come un film: per me è stato come riprendere delle scene di vita e avergli dato un senso con il montaggio. Il percorso va a ritroso: dai brani più recenti a quelli più lontani nel tempo, fino ad arrivare ai Preludi di Chopin che registrai nel 1979, al mio primo anno di conservatorio. Senza però propormi come interprete nel tipico senso della parola, tanto da non aver avuto problemi ad inserire pezzi che hanno degli errori di esecuzione – dichiarandolo nelle note di copertina: se devo sfidare un certo tecnicismo, devo avere anche il coraggio di riconoscere gli errori che rientrano all’interno di un’intenzione esecutiva, di non controllo razionale. Poi, ironia della sorte, vado a montare i pezzi e mi accorgo che il brano subito precedente a Chopin si conclude proprio con le due note che aprono il primo Preludio. Quasi come se l’autore del disco possa essere chiunque. Nel disco c’è anche un estratto dalla colonna sonora di A un millimetro dal cuore.
Forse l’unica definizione adatta per questo lavoro è quella di musica in forma libera. Un’operazione molto importante per me come uomo, sperando in un’ipotesi di cambiamento generale nel mondo musicale.
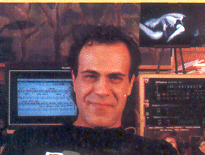
Risorse web: www.tonycarnevale.it