The Blue Max

Jerry Goldsmith
La caduta delle aquile (The Blue Max, 1966)
La-La Land Records LLLCD 1296 – Edizione limitata 2000 copie
Cd 1, 24 brani – Durata: 51’20”
Cd 2, 15 brani + 13 brani di additional music – Durata: 71’23”
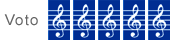

Jerry Goldsmith
La caduta delle aquile (The Blue Max, 1966)
e altre pagine di Jerry Goldsmith
City of Prague Philharmonic conducted by Nic Raine
Tadlow Music TADLOW 020
Cd 1, 22 brani – Durata: 65’07”
Cd 2, 18 brani – Durata: 67’18”
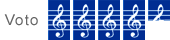
A distanza esatta di mezzo secolo, la partitura goldsmithiana per La caduta delle aquile, war-movie aviatorio del compianto John Guillermin ha assunto la piena fisionomia di un “classico” della musica per film, ed in particolare per questo genere (insieme a due altri gioielli come L’aquila solitaria di Waxman o I valorosi di Ròzsa): si tratta infatti di un lavoro appartenente già alla piena maturità del maestro californiano, dal respiro e dall’architettura imponenti, brulicante di invenzioni e intrecci leitmotivici, e come tale pronto ad essere annoverato tra quegli scores che si prestano a tutte le sfaccettature e le potenzialità dell’interpretazione musicale.
Ecco perché, a coronamento di un’ampia discografia sinora ruotante intorno a ristampe e riedizioni della OST, due uscite in doppio CD ed in quasi contemporanea ci ripropongono oggi questo capolavoro a stretto confronto tra una extended edition originale di spettacolare resa sonora grazie al prezioso lavoro di restauro compiuto da Mike Matessino, ed una riesecuzione, altrettanto ampia ed arricchita da numerosi stralci di altre partiture di Goldsmith, della benemerita City of Prague Philharmonic sotto la conduzione di Nic Raine.
Trattandosi di una partitura celebrata e molto studiata, la letteratura critica che la riguarda è come si può immaginare fiorente; e a questa potremo ora aggiungere a buon diritto le analisi minuziose e illuminanti che Jeff Bond e Julie Kirgo (per l’edizione La-La Land) e Frank DeWald (per la riesecuzione Tadlow) ci offrono nei rispettivi, corposi booklet. Tuttavia se un consiglio possiamo permetterci, è quello di disporsi all’ascolto di questo capolavoro come fosse una “prima volta”, così da poterne coglierne appieno la sconvolgente modernità e la sfolgorante bellezza. Come osserva Bond, il non ancora quarantenne Goldsmith è, a metà degli anni Sessanta, il compositore più richiesto e talentuoso della propria generazione (in quell’epoca l’astro di John Williams deve ancora sorgere pienamente): un talento costruito prevalentemente all’interno di un cinema fortemente connotato dai generi (poliziesco, avventuroso, guerra, commedie) ma nel quale spiccano titoli che hanno consentito al compositore di proiettare lo sguardo in avanti, incorporando nei propri scores suggestioni, stimoli e moduli tipici delle avanguardie musicali europee (si pensi solo a Freud, passioni segrete o Operazione diabolica). Si tratta di quell’impronta di modernità, a volte addirittura temeraria rispetto ai canoni hollywoodiani, che caratterizzerà sempre la produzione goldsmithiana, sino alle ultime fatiche degli anni ‘90 e primi 2000, dove a titoli spesso di basso rango qualitativo corrispondono partiture fulminanti per bellezza e coraggio stilistico.
Tratto da un racconto di Jack Hunter, il film descrive con sguardo critico e insieme partecipe l’ascesa e la caduta (letterali) di un ambizioso pilota da caccia tedesco (interpretato da George Peppard) impegnato sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale. Eroismo e propaganda, melodramma e tragedia, volontà di potenza e inevitabile soccombenza al fato sono i temi in sottotraccia, e bisogna dire che essi sono tutti racchiusi nell’imponente architettura musicale goldsmithiana, a cominciare dal celebre e assolutamente centrale motivo conduttore che debutta nei Main Title: un lunghissimo tema ascendente e spiraliforme, che s’innalza in un impennarsi di ampi intervalli attraverso archi e ottoni, imponendo una sensazione di ariosità e di svettante determinazione, al quale fa subito seguito in “The new arrival” una sorta di sua variazione in minore, più melodica e malinconica. Ferme restando per tutta la partitura queste due idee portanti, Goldsmith si produce in una serie di elaborazioni formali di straordinaria complessità: a testimoniarlo basterebbero il colossale fugato atonale di “First blood” o gli intrecci contrappuntistici del tema principale in “The captive”, idealmente contrapposti agli ottoni con sordina e agli accordi sommessi degli archi in “The Cobra”, evocanti un aspetto desolato e sinistro che non abbandona mai la partitura. Maestro insuperato nelle variazioni sui propri materiali, il compositore sottopone sia il “Blue Max theme” sia il fugato a riscritture di suprema fattura tecnica, come in “The attack”, incorporandovi fanfare brutali e serpentine evoluzioni dei legni, per raggiungere forse l’apice delle pagine action in “The bridge”: qui il tema principale si fa strada su uno staccato ostinato dei violini, passando da archi a corni e ottoni, con i legni sullo sfondo a guizzare senza sosta; il rintocco dei timpani aggiunge un sapore di inesorabile marcia tra il funebre e il militaresco, mentre l’insieme sprofonda alla fine in una serie di drammatiche dissonanze arricchite dalla presenza della macchina del vento.
Se il colore principale dello score è, come si vede, aggressivamente e modernamente acceso di tinte bellicose, non minore importanza hanno le parti liriche: sulle quali troneggia un Love Theme che, nel più schietto stile goldsmithiano, risuona contemporaneamente struggente e tristemente presago. “The retreat part 1 e 2” ripropone poi grandiosamente il rapporto di Goldsmith con le forme classiche, in questo caso una gigantesca passacaglia sulla quale i fiati riprendono i materiali di “The attack” passandoli di sezione in sezione, in una cattedrale progressivamente edificata per piani sonori strettamente correlati. Appare del tutto evidente, in ogni traccia e ogni momento di questa formidabile partitura, la concezione fortemente unitaria, e nel contempo straordinariamente variegata e mutevole, che governa il pensiero musicale goldsmithiano sin nel più piccolo dettaglio timbrico o contrappuntistico, garantito oltretutto dalla sua direzione d’orchestra implacabilmente analitica ma passionale; così come è sbalorditiva la temperatura emotiva ottenuta e tenuta costante, fra uno spirito avventuroso che celebra comunque l’audacia dell’animo umano e una visione tragica del destino che lo domina. Fino al congedo apparentemente consolatorio ma in realtà brusco e disperato degli “End title”.
L’album La-La Land è ulteriormente prezioso perché affianca, alla rimasterizzazione estesa della versione finale, anche la ristampa dell’album originale Capitol, arricchita da sette tracce di “source music” e sei di musica addizionale costituita da brani alternativi o inutilizzati nella versione ufficiale: il tutto a costituire un’operazione filologica, come nella tradizione di questa etichetta, di altissimo profilo.
La riesecuzione della City of Prague di Nic Raine conferma la consuetudine che la compagine praghese e il suo direttore hanno col repertorio goldsmithiano (ne ricordiamo la “Jerry Goldsmith Collection” del ’98 per l’etichetta Silva America): ma l’ascolto comparato con l’edizione originale diretta dall’autore regge a stento il confronto. Raine è un interprete diligente e preciso, dall’esperienza ormai consolidata in questo repertorio e l’orchestra gli risponde con un suono straordinariamente plastico e presente. Ma mancano dalla sua lettura il fuoco, la rabbia lucida, il nitore abbagliante dei timbri, della dinamica, del fraseggio goldsmithiani. L’esposizione del tema principale nei Main Title è elegante e sontuosa, ma le difetta l’accensione quasi demoniaca dello slancio originario; analogamente – per fare solo alcuni esempi – il fugato di “First blood” è più accademico che intimamente rivissuto, e in “The attack” il direttore britannico sceglie dei tempi troppo blandi e non sufficientemente imperiosi. Naturalmente si tratta di dettagli interpretativi e agogici, ma essi dimostrano quanto osservavamo all’inizio, e cioè come per queste grandi colonne portanti della musica cinematografica sia ormai possibile, e anzi doverosa, un’analisi anche sotto il profilo delle diverse interpretazioni che ne vengono offerte. Resta comunque il fatto che l’edizione Tadlow è una magnifica riproposta e rilettura complessiva di questo capolavoro, a merito della quale vanno aggiunte le ampie pagine supplementari che l’orchestra e il direttore offrono, relativamente ad altri titoli goldsmithiani.
Se la suite da MacArthur generale ribelle e due marce da Patton, generale d’acciaio, rimangono – con altre suites - all’interno del biopic bellico, sottolineando come Goldsmith ponesse in rilievo di entrambe queste figure anche gli aspetti ambigui e sfuggenti (soprattutto nella marcia vagamente onirica e minacciosa del secondo), e la suite da La veglia delle aquile ha il merito di offrire scampoli di uno score goldsmithiano poco noto, gli altri estratti valorizzano perfettamente i pregi dell’orchestra praghese e l’acutezza delle sue scelte. La suite da Quelli della San Pablo esalta gli aspetti tragici e crepuscolari del sinfonismo goldsmithiano, attraverso una estrema varietà di colori e sfumature orchestrali, mentre Inchon (altro titolo “minore” della sua filmografia) stempera l’esotismo di maniera in una lezione di stile e sobrietà, e i titoli di Tora! Tora! Tora! scandiscono attraverso l’aggressiva modernità armonica e la furiosa ritmica un senso di inesorabile predestinazione.
Fuori dal genere bellico, la suite da La lunga ombra gialla evidenzia la sottigliezza, mai meramente esornativa, del rapporto di Goldsmith con i materiali “locali” (qui cinese e orientale in genere), sempre assorbiti all’interno di una scrittura raffinatissima e moderna, mentre La mummia attesta la travolgente freschezza della parte finale della carriera goldsmithiana, attraverso un sinfonismo frastagliato, pittoresco e irresistibilmente autoironico; ed il conclusivo Conflitto finale, secondo sequel di quel capolavoro musicale che fu Il presagio, ribadisce che per questo maestro il concetto di “routine” non esisteva proprio. Ogni occasione, anche la più commerciale o di maniera, era per lui lo spunto di nuove ricerche, nuove invenzioni, nuove elaborazioni formali (qui, come altrove, spicca l’utilizzo magistrale del coro); la voce della modernità era per Jerry Goldsmith un richiamo fortissimo e primario, e l’indipendenza della musica anche se applicata al cinema costituiva un dettato etico, prima ancora che estetico. Questo, a quasi novant’anni dalla sua nascita e dodici dalla scomparsa, ne fa ancora oggi alle nostre orecchie un genio senza eguali.