The Neon Demon
 Cliff Martinez
Cliff Martinez
The Neon Demon (Id., 2016)
Milan Music 36785-2
20 brani + 3 canzoni – Durata: 69’42”
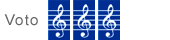
A Cliff Martinez non piacciono né si addicono le cose facili; se così fosse, non si sarebbe legato a cineasti imprevedibili e ondivaghi nello stile (e quindi nelle esigenze musicali) come Steven Soderbergh – con cui ha allacciato la collaborazione più prolifica – ma anche Harmony Korine, Xavier Gianoli e ora il “terribile” danese Nicolas Winding Refn, visionario e vulcanico, sanguinario e lirico talento dall'ispirazione nevroticamente centrifuga.
Iniziato con Drive e proseguito con Solo Dio perdona, il sodalizio approda ora al terzo capitolo di una ricerca sonora dove nulla è precluso né interdetto e dove non è il fine a giustificare i mezzi, bensì l'esatto opposto. Questo thriller feroce e translucido sul mondo della moda, una via di mezzo fra Prêt-à-porter di Altman e Viale del tramonto ripensati sotto effetto di droghe pesanti, sembra quasi il laboratorio ideale per uno score dove non c'è praticamente una nota di suono acustico, ma nel quale per contro l'impiego massivo e differenziato del sound elettronico acquista una valenza espressiva ed una potenza d'atmosfere sconosciute ad altre prove assimilabili. Ciò si deve innanzitutto al fatto che tutto questo lavoro pulsa e vibra di un'intensità armonica accorata e a tratti struggente, facendo uscire dalle lunghe fasce sonore computerizzate accordi di celestiale bellezza e tristezza (“Gold paint shoot”) o tenui, impalpabili nuances timbriche che paiono provenire da un irraggiungibile iperuranio. La componente ritmica, ossessiva e geometrica (“Neon Demon” o “Jesse sneaks into her room”) rimanda peraltro a reminiscenze del “rock progressive”, mentre l'inserzione di campanelli, tintinnìì, effetti carillonistici (“What are you”) ricorda addirittura i nostri Goblin (d'altronde è conclamata l'ammirazione di Refn per il cinema di Dario Argento). In realtà, le influenze dichiarate da Martinez sono molteplici: si avvertono echi della Kosmische Musik di gruppi storici come i Tangerine Dream o i Popol Vuh, ma anche di Brian Eno e della sua ambience music: il tutto è però esasperato in una incessante ricerca di effetti bizzarramente evocativi (“Real Lolita rides again”), lontanissimi da qualsiasi tentazione filosofica New Age e piuttosto chiaramente indirizzati a costruire un sound design in linea con la fortissima impronta onirica e pittorica del film: a volte con punte di una bellezza disarmante (“Runway”, che sembra quasi ispirarsi alla visione di un'aurora boreale, o la trasognata “Who wants sour milk”), altre con ripetitiva insistenza su una programmazione del suono come mero sottofondo ad effetto (“Would never say you're fat”, “Thanks God you're awake remix”).
Prevale tuttavia un edonismo melodico provocatoriamente compiaciuto e articolato secondo strutture armoniche e linee melodiche a tratti molto orecchiabili (“Kinky”), persino quando interviene un clima abbastanza funereo, con sonorità che richiamano quelle del vecchio Theremin (“Ruby's close up”); oppure nello sconfinare nel rumore puro, come in “Lipstick drawing”. Ora, è del tutto evidente che alla distanza l'effetto che una simile partitura provoca – e con esso il rischio che corre – è quello di un ipnotismo acustico vagamente soporifero e straniante, specie quando il compositore americano rinuncia a occuparsi dell'architettura complessiva per concentrarsi su qualche elemento ornamentale secondario (riverberi, distorsioni, dissolvenze acustiche, alterazioni di profondità dal basso profondo al sovracuto, tipo “Something's in my room”). Sono i momenti in cui prevale un concetto di scenografia musicale decorativa e piuttosto banale, al di là dei mezzi utilizzati; vale ad esempio per la lunga “Are we having a party”, basata su un ritmo immutato e monocorde nello sviluppo, solo in coda nobilitato da un specie di effetto “trombe degli angeli”. Ma nel complesso rimane perentoria l'impressione di un lavoro decisamente fuori dal comune, nel quale tra l'altro Martinez è stato coadiuvato da collaboratori preziosi come Peter G.Adams e Gregory Tripi (quest'ultimo autore fra le altre delle scores di Dark Places e Road to Moloch); mentre un ruolo coerente con l'insieme e ad esso funzionale svolgono l'esagitata “Mine”, scritta dal cugino del regista Julian Winding ed eseguita dalla band anglo-danese Sweet Tempest, “Demon dance” sempre di Winding e “Waving goodbye” dell'onnipresente cantautrice australiana “Sia”, chiamata in causa sia per una sciocchezza rumorosa come Wonder woman che per un film dai caratteri certo non facili né sempre condivisibili, ma certamente sperimentali, come questo.