Dunkirk & Blade Runner 2049

Hans Zimmer, Lorne Balfe, Benjamin Wallfisch
Dunkirk (Id., 2017)
Sony Classical 88985461482
11 brani – Durata: 59’03”
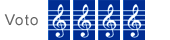

Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch
Blade Runner 2049 (Id., 2017)
ASG Records/Epic Records (Digital Media)
19 brani + 5 canzoni – Durata: 95’00”
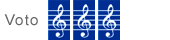
Se fossimo in vena di iperboli, potremmo chiamarle “Hans Zimmer’s ultimate movie scores”. Ma di iperboli pro e contro, a proposito del compositore anglo-tedesco, ce ne sono già in abbondanza e abbondantemente a sproposito. Inoltre di “ultimativo”, nel senso di definitivo, di punto di non ritorno, queste due recenti partiture, abbinate ad altrettanti titoli forse tra i più attesi della stagione, non sembrano avere molto. Anzi l’impressione è che la ricerca di Zimmer sia in un certo senso appena agli inizi, o quantomeno giunta ad una delle numerose svolte che hanno caratterizzato la sua ormai 35ennale carriera.
E allora converrà partire proprio da qui, ossia dall’atteggiamento sperimentale, sino alla vera e propria provocazione acustica, che il compositore sembra aver assunto da qualche anno a questa parte. Un posizionamento che lo porta decisamente fuori dalle convenzioni e dalla tradizione, rendendo i suoi lavori particolarmente ostici anche a chi ne aveva amato la grandiosità monumentale, postwagneriana raggiunta tra gli anni Novanta e Duemila. Anche chi aveva ammirato le cattedrali sonore incombenti e apocalittiche di Inception, ad esempio (per restare dentro il cinema di Christopher Nolan, regista con cui Zimmer ha ormai intrapreso un duraturo sodalizio) faticherà a familiarizzare con la sconvolgente “palette” di Dunkirk, e per un semplice motivo: qui Zimmer assume infatti il ruolo e i compiti di uno scenografo sonoro (o “sound designer”) al servizio più che mai delle scomposizioni spaziotemporali del regista, in più con l’esigenza di avvolgere gli eventi storico-bellici narrati in una cornice antinaturalistica al massimo, quindi scevra da qualsiasi immediatezza comunicativa o convenzionale ma al contrario sovraccarica di una specie di predestinazione tragica, restituita attraverso ritmiche ossessionanti, suoni come respiri dalle viscere della terra o dalle anime dei soldati caduti, progressioni dinamiche protese fino all’insostenibilità. L’elettronica diventa insomma qui non mezzo ma fine, architettura portante di un paesaggio musicale “alieno”, destrutturato e non-umano, nel quale si affacciano di tanto in tanto spiragli di sentimento o ultimi bagliori di un crepuscolo lirico ormai inarrestabile, magari attraverso qualche ottimistica citazione elgariana...
La score è composta da 11 brani molto lunghi, quasi altrettante suite, che sostanzialmente ruotano intorno ad una parvenza di “tema”, una implacabile scala ascendente che trascina tutte le fasce sonore verso un “la” inchiodato dai synth ad una ripetitività da incubo (“Submarine”). All’esterno di questo nucleo incandescente si muovono dei “cluster” oscillanti (da “The mole” a “The tide”), sottoposti a minime variazioni, secondo uno schema che trova nella figura del crescendo (lo spaventoso “The oil”) la propria ragion d’essere e al contempo la propria terrificante vocazione dissolutoria. Anche se “Home” (composto insieme al sodale Benjamin Wallfisch, autore in proprio e non a caso dei più concilianti e rasserenanti “Variation 15” e “End titles”, mentre un altro fedelissimo zimmeriano come Lorne Balfe è co-autore di “Regimental brothers”) sembra riportare un po’ di luce timbrica e tonale in fondo al tunnel, a prevalere nettamente è una specie di nichilismo timbrico che a tratti (“Impulse”) ricorda Inception ma in una versione decisamente più radicale e meno gratificante.
Il seguito del capolavoro di Ridley Scott era poi particolarmente atteso da chi si illudeva di poter tracciare parallelismi con il lavoro dell’82 di Vangelis Papathanassiou, che all’epoca fu considerato un esperimento pionieristico nel campo della musica per film elettronica. Ma la partitura dell’ex-Aphrodite Child vibrava di un umanesimo intrinseco, accalorato e poetico, che nelle sonorità sintetizzate toccava se possibile punte di ancor più spiccato potere emozionale, tant’è vero che fu abbastanza agevole poi ricavarne una versione orchestrale. Qui invece Zimmer – stavolta in collaborazione continua con Wallfisch - il quale nel frattempo firma di suo egregie partiture horror come Annabelle: Creation e il nuovo It – non dedica al tema di Vanglis che una rapida, formale citazione finale (“Tears in the rain”), ricercando invece una specie di “mystic sound” intessuto di lunghi pedali e fasciature avviluppanti (“Rain”, “Wallace”) che non sembrano porsi come obiettivo alcuna forma chiusa o precostituita. Il risultato è un tapis roulant, un continuum indifferenziato che senza dubbio avrebbe avuto una resa migliore nelle mani di Jóhann Jóhannsson, il talentuoso islandese inizialmente incaricato, già caro al regista Denis Villeneuve e per lui recentemente autore del pregevole Arrival. Viceversa, nel tentativo di ricreare aggiornandolo il sound di Vangelis, il duo Zimmer-Wallfisch sembra piuttosto intimidito e schiacciato lungo un piano di ingegneria sonora (“Orphanage”, “Furnace”, “Mesa” e tanti altri tracks) che aborre il naturalismo sonoro ma solo in virtù di un’astrazione estrema, ostentata e verticale (“Someone lived to this”), anche probabilmente nell’intento di creare un evidente contrasto con alcune canzoni vintage come “Can’t help falling in love” di Elvis o “Summer wind” di Sinatra.
Anche qui i brani hanno lunghezze smisurate, da suite autonome, come “Sea Wall” e la finale “Blade runner”, intorno ai 10 minuti, proprio perché Zimmer e Wallfisch rifiutano l’idea di traccia chiusa e preferiscono affidarsi a sequenze sonore totalizzanti e ipnotiche. L’operazione non è di per sé priva di fascino, perché i talenti in campo sono notevoli e comunque il contesto filmico si presta a riflessioni linguistiche e tecniche oltre i confini del già visto e sentito; e quindi accade che qua e là si accendano momenti emozionanti (“All the best memories are hers”), lampi di tonalità minore struggenti, lacerti melodici subito abbandonati.
Ma, come dicevamo all’inizio, la sensazione è che Zimmer intenda saltare, d’ora in avanti, le trappole che lui stesso si è costruito circondandosi di zelanti adepti non sempre all’altezza e devoti solo ad uno “zimmerismo” di facciata, cercando nuove strade, nuovi percorsi espressivi a costo di creare irritazione e incomprensione, e di negarsi – poco ma sicuro – ad un facile e piacevole ascolto. Non sappiamo dove potrà portarlo questa ricerca. E probabilmente neanche lui.