The Post
 John Williams
John Williams
The Post (Id., 2018)
Sony Classical 19075811342
10 brani – Durata: 40’14”
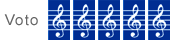
La buona sorte (aiutata da scadenze favorevoli) ha evitato il ripetersi di quanto accaduto nel 2015, allorché la concomitanza dell’Episode VII di Star Wars e de Il ponte delle spie dovette interrompere per la seconda volta in un quarantennio lo storico sodalizio fra John Williams e Steven Spielberg, affidando la relativa score a Thomas Newman. Stavolta, infatti, la strettissima vicinanza temporale con Gli ultimi Jedi non ha impedito all’86enne maestro americano di consegnare il capitolo 28 di una collaborazione ormai entrata nella storia, e del cinema e della musica: anche se sappiamo già che il prossimo titolo spielberghiano, Ready Player One, dall’omonimo romanzo di fantascienza di Ernst Cline, segnerà una nuova interruzione, marcando peraltro il primo incontro “ravvicinato” tra il regista e Alan Silvestri.
Per argomento, stile e impianto narrativo, The Post appartiene al filone diciamo così “realista” di Spielberg, costruendo un vero e proprio docudrama politico-giornalistico intorno alle vicende che videro la leggendaria testata di Washington denunciare i misfatti dei cosiddetti “Vietnam Papers”, preparandosi poi a svelare la madre di tutti gli scandali americani, ossia il Watergate. Ne discende, per il compositore, la necessità di adottare un linguaggio scabro, modernamente irrequieto, privo di qualsiasi enfasi o afflato eroico-romantico: è “l’altro” Williams, insomma, che ben conosciamo e che ne ha sempre accompagnato in parallelo la produzione più spettacolare e sinfonicamente rutilante. Non è un caso che sin da “The Papers” e “Presses roll” facciano capolino echi da partiture come The Terminal, Turista per caso, Presunto innocente: ossia lavori dove l’aspetto privato, umano, l’intrigo psicologico, la suspense sostituiscono a pieno diritto quello fantastico e visionario di cui Williams è l’impareggiabile affrescatore sonoro. In “The Papers” per esempio, si fa subito largo un colore orchestrale scuro, misterioso, grave, sorretto da discreti ma pulsanti effetti elettronici di sostegno, con rapidi disegni dei legni che ricordano quelli di Prova a prendermi, sia pur depurati da qualsiasi intento satirico. In “Presses roll” invece l’incalzare degli staccati degli archi in serrati crescendo ottiene, con una sapiente economia di risorse, l’effetto di una tensione stringente e diffusa, accresciuta nel minaccioso “Nixon’s order” dal sommesso e inestricabile ringhio dissonante dei bassi.
Questo universo di suoni, così “metropolitano”, notturno e asciutto, antiretorico, è familiare da decenni al maestro newyorkese: probabilmente sin dagli albori della sua splendida carriera, quando operava come pianista jazz e di “easy listening”. Ecco come si spiega la freschezza insieme malinconica e sorridente di due pagine tipicamente da piano-bar come “The Oak’s room, 1971” e “Two Martini lunch”, dove l’apparente svagatezza del piano solista accompagnato dal basso ripropone un atteggiamento solitariamente nostalgico e struggentemente lirico che ricorda il Mancini di “It’s easy to say” da 10, o – ma in versione molto più scarnificata - il Barry di “Fun city” da Un uomo da marciapiede.
Alla guida di un’orchestra dai colori trasparenti, mai così nitidamente impressionistici, Williams inanella pazientemente una serie di pagine impreziosite dal suo inconfondibile tocco armonico politonale, insistendo per quanto riguarda le fasi più agitate sulla semplice combinazione staccato-crescendo (“Setting the type”) e appellandosi nei momenti più intimi e privati ad un lirismo melodico che si è ormai fatto sublime saggezza e magistero compositivo, come in “Mother and daughter”, dove nell’andamento colloquiale, discorsivo e tenuemente mesto si può anche ascoltare, brevissimo ma indimenticabile, un miniepisodio centrale di pochi secondi affidato al corale dei corni, strumenti prediletti da Williams.
Esplorando la sezione degli archi in ogni anfratto, occultando le idee leitmotiviche (presenti, ma quasi timide ad esporsi) in un sofisticato tessuto contrappuntistico, il compositore tocca punte estreme e penetranti di rarefatta sottrazione emotiva, come in “Deciding to publish”, aperta da accordi acuti e sospesi dei violini sul registro acuto, intervallati da risposte dei celli e bassi, prima di iniziare sempre nei celli la ripetizione infinita di un breve motto poi ripreso dai legni, che esprime più inquietudine di quanta potrebbe produrne qualsiasi sfoggio muscolare orchestrale.
La score, parca anche nella durata, sfocia negli oltre undici minuti conclusivi di “The Court’s decision/End titles”, pagina assolutamente autonoma e autoconclusa, che ci auguriamo di veder d’ora in poi inserita nei programmi concertistici dedicati al maestro: Williams vi continua e sigilla la riflessione sul colore strumentale e sull’idea di un’”azione” che è prima di tutto mentale e psicologica. Così, la prima parte del brano si muove in uno snodo lento, nobile e pensoso degli archi, mentre la seconda s’impenna per la prima e ultima volta in tutto il lavoro attraverso un sapiente gioco di rimbalzi fra ottoni, archi, timpani, il cui sviluppo presenta tutte le caratteristiche di complessità e insieme chiarezza che sono tipiche del compositore, per chiudersi poi quasi inavvertitamente, ancora sottovoce, nel fraseggio del piano.
Al di là del perdurante stupore per l’immediatezza, il rigore e l’affascinante delicatezza di tocco dell’anziano maestro, va sottolineato che una simile partitura nella sua composta severità formale costituisce anche un ottimo antidoto preventivo a qualsiasi tentazione apologetica o idealizzante possa emergere (ed emerge in effetti, sia pur tenuta a freno) dal film di Spielberg. Del resto sia il regista che il musicista sono cittadini illustri, ma anche critici, di un’America che non consente oggi alcun ottimismo.