Jackie
 Mica Levi
Mica Levi
Jackie (Id., 2016)
Milan Music 399 877-2
14 brani – Durata: 34’09”
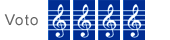
Sono trascorsi solo cinque anni dal sensazionale debutto nella musica per film di Mica Levi, cantautrice britannica trentenne decisamente “alternativa”, con il fantascientifico e perturbante Under the Skin, e si può affermare che per la giovane compositrice sia iniziata una nuova carriera. Dopo il film di Jonathan Glazer e dopo questo biopic su Jackie Kennedy a firma di Pablo Larraìn, la Levi è stata infatti coinvolta in alcuni corti ma soprattutto in una nuova prova di fantascienza “etica”, Marjorie Prime di Michael Almereyda, e più recentemente nel thriller Monos di Alejandro Landes. Sono terreni dove l’artista, nota nel mondo del rock sperimentale come Micachu, ha evidentemente trovato ottima linfa per un laboratorio sonoro che non somiglia a quello di nessun’altra figura emergente degli ultimi anni.
In Under the Skin l’assunto centrale (l’aliena-“mantide” Scarlett Johansson costretta a confrontarsi con la propria corporeità e sessualità in un universo maschile potenzialmente ostile) trovava nella partitura della Levi tonalità malate, insinuanti e fascinosamente “dark” grazie all’individuazione di semplici cellule melodiche (pochissime note ripetute, una sorta di marchio di fabbrica ultraminimalista) e alla distorsione timbrica di alcuni strumenti, prevalentemente ad arco.
Qui il contesto è apparentemente più tradizionale, trattandosi di una biografia (anomala e a-politica) di Jackie Kennedy, interpretata da Natalie Portman, sospesa in una sorta di limbo psicologico, freddo e atemporale, in cui emerge il personaggio della protagonista in tutta la propria solitudine, allineandosi in questo con tutto il cinema – altre volte assai più aspro e ultimativo – di Larraìn. Un tandem dunque decisamente singolare, quello formato dalla popstar inglese e dal rigoroso regista cileno di Tony Manero e Post mortem, che si fonda naturalmente sulla negazione di molte convenzioni consolidate nel rapporto tra musica e racconto.
A cominciare da quello della corrispondenza “apparente” fra i due elementi. La Levi infatti lavora sulla base di uno spiccato asincronismo psicologico per il quale a determinate immagini non corrispondono affatto i toni musicali che ci si aspetterebbe di udire (in questo rifacendosi addirittura, forse inconsapevolmente, ad alcuni esperimenti di asincronismo propri delle avanguardie sovietiche!). Inoltre l’assenza di verve polemica o di ambizioni da film-inchiesta (Larraìn non è Oliver Stone, non gli interessa riaprire il caso Kennedy) spinge la compositrice a spendersi molto sul piano squisitamente umano, emozionale e di partecipazione al dolore della protagonista. Naturalmente, a modo suo…
L’organico prevede una vasta e pastosa sezione di archi, circa quaranta elementi, cui si affiancano un pianoforte, alcuni legni solisti, vibrafono e celesta. Ne esce un suono non immemore di influenze herrmanniane (pensiamo alle pagine più raccolte e pacatamente mortuarie di Psycho), morbido e accattivante nel timbro quanto spiazzante e disturbato nel registro armonico, anche se più conciliante rispetto a Under the Skin.
La successione di tre accordi discendenti, strascicati e sofferenti, in la, la bemolle e sol, ripetuti all’ottava bassa, dell’”Intro”, declina immediatamente il colore interiore della partitura, che tra l’altro il regista ha avuto l’intelligenza di mixare a volume molto alto nel film, così da conferirle un rilievo assolutamente inequivocabile e impossibile da ignorare. L’inserimento di un clarinetto, solitario e dissonante, crea poi quel fattore di disagio, di malessere che accompagnerà tutta la score. Non è da meno “Children”: la ripetizione ossessiva e cadenzata di mi bemolle e re bemolle accoglie nelle viole un la bemolle che, insieme alle prime due, costruisce una specie di ninna nanna cromatica blanda e allucinata, sulla quale intervengono un distante rullo di tamburo e tamburello e un disegno spettrale, fluorescente del flauto; l’effetto è agghiacciante e insieme di grande pathos, ottenuto con un’assoluta economia di mezzi e di opzioni armoniche.
Così “Car”, che corrisponde ad una sequenza d’azione, non è che un velocissimo susseguirsi di tremoli allarmati dal registro grave a quello acuto, mentre “Tears” sottolinea una delle sequenze più toccanti (Jackie che si pulisce il vestito dal sangue e dalla materia cerebrale di Kennedy nella toilette dell’aereo dove Johnson sta giurando) con smorti accordi pianistici e di celesta, sempre intessuti su tremoli e brividi degli archi. Le enunciazioni sono brevi, le arcate dinamiche non superano mai il mezzoforte. D’altronde non c’è alcun bisogno di gridare quando ciò che si sussurra ha questa forza di persuasione occulta.
Ancora pochissime note, due, iterate dal flauto su un reticolato ondulatorio e apertamente atonale degli archi, sostengono in “Autopsy” il rullo ricorrente del tamburo, che è l’unico strumento preposto ad evocare una sinistra marzialità militare, ben nota ad un regista che ha vissuto nel Cile di Pinochet… Straordinaria è “Empty White House”, intenso epicedio funebre in tonalità minore caratterizzato da lunghissime pause che frammentano il fraseggio dandogli un carattere di ansiosa provvisorietà; non meno che “Graveyard”, vera e propria marcia funebre basata su incessanti coppie di accordi pianistici sorretti dal tremolo degli archi e dal rullare di un tamburo che, qui, sembra quasi proporre una versione minimalista, prosciugata del “Prologue” di Williams dal JFK di Stone. “Lee Harvey Oswald” riprende poi i materiali dell’”Intro” ma in una forma se possibile ancor più raggelata, mentre “Walk the Capitol” ripropone una forma processionale, rituale basata sulla ripetizione di tre note ma intervallate da tremoli il cui accento si sposta continuamente in modo asimmetrico. La severità della scrittura per archi può apparire sorprendente in una musicista dalla formazione apparentemente pop, ma non va dimenticato che Mica Levi viene da una famiglia di compositori classici e ha comunque compiuto studi nella prestigiosa Guildhall School of Music & Drama di Londra. Questo spiega ad esempio il rigore concettuale di una pagina come “Vanity”, dove il colore scuro e gli accenti da requiem, quasi mahleriani, degli archi gravi ancora una volta impegnati in lente triadi di accordi, vengono illuminati dall’arabesco fiorito del flauto; e dopo la brevissima parentesi rasserenante di “Decision made”, ecco ricomparire in “Burial” un’atmosfera di tensione e instabilità nel susseguirsi degli onnipresenti tremoli in crescendo e diminuendo.
Le continue modulazioni intorno all’accordo di do maggiore di “The end”, pagina dallo spiccato, estenuato cromatismo, evocano una dolente rassegnazione esplicitata nel canto dei primi violini, cui si aggiungono clarinetto basso e flauto, in quello che è forse il momento più “sentimentale” e affettuoso della partitura; che si chiude però con i “Credits”, altro straordinario esquisse musicale in filigrana sottilissima, con i tremoli sussurranti e timidi degli archi continuamente interrotti e intervallati dagli arpeggi del vibrafono.
Congedo sospeso e interrogativo, non “risolto”, per una partitura di rara intelligenza speculativa e fortissima carica espressiva: tanto più forte in quanto ottenuta con estrema parsimonia di mezzi. Una formula che fa probabilmente di Mica Levi una compositrice destinata ad essere molto contesa dai registi che hanno a cuore tanto il potere delle emozioni quanto la sobrietà del linguaggio.