26 Giu2012
Antonioni e la musica
 Roberto Calabretto
Roberto Calabretto
Antonioni e la musica
Saggi Marsilio, 2012, pagg. 206, € 20
http://www.marsilioeditori.it/
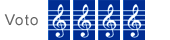
Tutto da definire, ovviamente, il concetto di “musica realistica”, così come tutte da circostanziare e circoscrivere “banalità” e “scontatezza” della musica per film italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Di cosa parliamo e di chi? Della musica per il cinema postneorealista e dei suoi cascami postveristi o della spinta innovativa già in agguato con Nascimbene prima e Morricone poi? Del jazz contratto e non meno “realistico” di Piero Piccioni per il cinema di Francesco Rosi o dell’universo poetico parallelo di Nino Rota per quello di Fellini?
Anche sospendendo questi interrogativi, resta chiaro e limpido il nocciolo della questione: Antonioni rifiutava la musica come “sovrapposizione” emotiva alle immagini, come sottolineatura, come linguaggio e/o valore aggiunto. La musica viene in lui sottoposta ad un continuo, estenuante lavorìo di prosciugamento, di sottrazione, di essiccazione, ben documentato dalle testimonianze di Giovanni Fusco, il profetico e modernissimo musicista del primo Antonioni, quando racconta come le sue già scarne, spettrali, cameristiche partiture venissero ulteriormente deprivate, silenziate, annichilite dai diktat del regista in sala di montaggio; o dalle dichiarazioni di Herbie Hancock e dei Pink Floyd, reclutati rispettivamente per Blow Up e Zabriskie Point, il cui lavoro fu egualmente decurtato e minimalizzato dal regista in una sorta di cupio dissolvi sonoro che tendeva, di fatto, a omologare musica, suono e rumore in un'unica identità percettiva.
La paziente perlustrazione di Calabretto, arricchita da esempi musicali e visivi, segue la linea di estrema coerenza antonioniana lungo questo percorso, dalla “trilogia dell’incomunicabilità” a Deserto rosso, sino alla svolta pop degli anni ’60-’70 e alla radicalizazzione di Professione reporter, per arrivare alla riflessione (disastrosa, sotto il profilo estetico) de Il mistero di Oberwald e alle ultime, malinconiche opere. Un itinerario che passa anche, naturalmente, attraverso il cospicuo utilizzo di musica preesistente e culturalmente referenziale (Oberwald, con Richard Strauss e Schönberg: nulla a che fare dunque – anzi – con le fulminanti decontestualizzazioni e le astrazioni kubrickiane) o comunque di musica “di consumo” giovanilista, dal twist di Mina in L’eclisse al Lucio Dalla di Al di là delle nuvole, sempre intesa perciò come musica di riferimento iconico o situazionistico, mai – per carità!... - come elemento di ricerca autonoma o di libera espressività di un linguaggio a sé stante. Un approccio, quello di Antonioni al pop-rock, che nell’84 conobbe anche lo sconsolante episodio del videoclip di “Fotoromanza“ di Gianna Nannini, dove i versi della canzone («Questo amore è una camera a gas») sono visualizzati alla lettera dal regista (del gas che filtra da sotto una porta!) con un didascalismo che non si sa se definire ingenuo, canzonatorio (ne dubitiamo) o semplicemente senile.
Dentro questa gabbia il ruolo della musica nel cinema antonioniano si è rivelato a suo modo decisivo nella definizione della poetica del regista e nella circoscrizione del suo universo linguistico, pur negandosi in prospettiva a qualunque “identificazione di uno stile” o di un approccio dai contorni precisabili. A differenza di altri registi che hanno quasi drasticamente rifiutato l’uso della musica nel proprio cinema (come Bresson, Tarkovskij o Buñuel), Antonioni ne subordina i compiti e le funzioni ad una supremazia generale della dimensione sonora come integrazione alla dimensione visiva, svincolando quindi i suoni (le note) da qualsiasi legame o destino di comunicazione, e puntando anzi ad una intransigente, criptica e vagamente fondamentalistica concezione antiretorica della musica.
L’indagine di Calabretto, nella sua scintillante laboratorialità, ci restituisce intatti e inappellabili questo itinerario e questa ideologia estetica, di cui oggi gli spettatori che volessero riaccostarsi all’opera di un grandissimo e distantissimo maestro sono chiamati a distinguere i pregi dalle contraddizioni, le ovvietà cultural-intellettuali dalle intuizioni, gli snobismi in provetta dalle incancellabili conquiste di modernità.