Il cinema è mito. Vita e film di Sergio Leone
 Marcello Garofalo
Marcello Garofalo
Il cinema è mito. Vita e film di Sergio Leone (2020)
Roma, Minimum Fax
pp. 537
€ 20,00
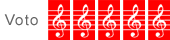
[…] l’esistenza di un primo e assoluto leone, di cui tutti i diversi leoni particolari e approssimativi che ci balzano contro sono solo ombre o parvenze. (Italo Calvino, Ti con zero)
Il Patriarca, il grande viso lievemente stempiato, capelli, barba, ispidi baffi biondobrizzolati, spessi occhiali di tartaruga, fissa attraverso l’unico occhio visibile (il volto è illuminato per tre quarti, il resto in ombra) dall’iride indefinita un punto lontano sopra di noi ed oltre noi, situato in un non-luogo che solo lui vede, spazio/tempo altri impressi sulla retina, campo di possibilità che si tradurranno in immagini di celluloide e volti e movimenti e suoni. Una luce calda, aranciata illumina il quasi primo piano, non c’è sfondo: solo quel volto, quello sguardo benevoli onnicomprensivi di saggio antico, di profeta, di veggente.
Il ritratto in copertina della monografia di Marcello Garofalo Il cinema è mito. Vita e film di Sergio Leone ci restituisce in un’istantanea formidabile la mente immaginifica del grande cineasta scomparso a sessant’anni il 30 aprile 1989 aprendo nella settima arte una voragine paurosa e lasciando in sospeso un nuovo progetto mastodontico che nessuno osa toccare.
Gli inizi furono grandiosi al botteghino, disastrosi in sede critica. Non si negarono l’abilità tecnica, la professionalità (pur se ci fu chi lo confinò nell’anonima schiera dei “buoni e onesti artigiani”) (1). Furono stigmatizzati per contro la violenza in primo luogo, e poi il (presunto) manierismo estetizzante ed autocompiaciuto. Per non parlare delle accuse di “lentezza” a partire da C’era una volta il West (“Leone ha la pedalata lenta” scrisse da qualche parte Giovanni Grazzini; e Tullio Kezich: “nel tempo che lui ci mette a fare i titoli, un western dell’epoca d’oro sarebbe già a metà dell’avventura” (2). Qualcuno lo definì “astutissimo mestierante” (3). Ma fu soprattutto la «violenza» a indispettire una critica avvezza ai toni pacati del western americano (ma già Peckinpah con The Deadly Companions del 1961 aveva iniziato una revisione proseguita nelle pellicole successive) e comunque d’impronta contenutistico-pedagogica. Così, Kezich ancora, su Per un pugno di dollari: “C’è tuttavia qualcosa di eccessivo, che denuncia la mancata appartenenza a un filone originario. Abbiamo visto western violenti e cruenti di marca americana, ma in Per un pugno di dollari si esagera: stragi salgariane, torture sadiche, sangue che imbratta tutto il film. E nessun legame, ormai, con i miti della giustizia, della fantasia e della libertà così vivi nel «western» classico. Dall’avventura donchisciottesca dello sceriffo senza macchia siamo passati a un catalogo di efferatezze senza giustificazione poetica o narrativa. I ragazzi vanno tenuti lontani da questa scuola di violenza; ma gli adulti che cosa possono trovarvi all’infuori di uno sfogo dell’istinto di sopraffazione? Se ci deve essere una via italiana del «western», vogliamo che sia proprio caratterizzata dai calci nelle costole e dai pugni sul naso?” (4). Gian Piero Dell’Acqua rincalzava: “[il film] è un’orgia di qualunquistica violenza, con più di un particolare di pesante volgarità […] è in se stesso deforme, lugubre, triviale ed è probabilmente piaciuto per questi motivi” (5). Anche Luigi Cavicchioli, che pure aveva omaggiato i primi due atti della trilogia, arrivati al terzo ci dà dentro: “Sergio Leone, che con i primi due film ci aveva offerto un perfetto esempio di western italiano, non ha saputo rinterzare […]. Qui di buono non c’è niente, solo bruttezza, cattiveria, bassa macelleria” (6). Mario Soldati, del quale Leone era stato aiuto in I tre corsari e Jolanda la figlia del corsaro nero negli anni 1952-53, definì Per un pugno di dollari “ripugnante” oltre che mal fotografato, con “difficoltà di dialogo” e incongruenze, amato da un pubblico attratto dallo spettacolo di una “violenza finta e falsa” (7). Invece la violenza, quella cruda, e la «macelleria», sarebbero arrivate dopo con Django di Sergio Corbucci (1966), il tremendo Se sei vivo spara (1967) di Giulio Questi, l’orripilante I quattro dell’apocalisse (1975) di Lucio Fulci. In Leone invece la messa in scena degli scontri, e della morte, non si rivolge ai visceri dello spettatore bensì al suo immaginario sentimentale – epico, lirico, ironico -; suscita ammirazione, commozione, coinvolge e non disgusta mai: proprio come non prova ribrezzo il bambino che gioca alla guerra. La crudeltà del suo cinema non è lo spettacolo del sangue: piuttosto, l’orrore del vivere come “stato violento” che, abbandonata la prospettiva ludica, «giovanile» dei primi film, diviene esperienza del male e della delusione: percorso che approda a C’era una volta in America, opera davvero ultraviolenta nella sua amarezza che nemmeno l’enigmatico sorriso di Noodles riesce a dissipare.
Con i primi due capitoli della seconda trilogia non andò meglio; con la differenza che, accantonati o quasi gli strali contro la «violenza», si presero di mira «l’affettazione» e la «megalomania». Esemplare Morandini su C’era una volta il West: “Sergio Leone, dotato di una certa muscolarità espressiva, ha i suoi limiti nel manierismo che accompagna ogni suo film. Cinismo, violenza e autocompiacimento sono conditi dalla musica ingombrante del suo omologo in campo musicale, Ennio Morricone. […] Il montaggio è solo un espediente per le anime semplici. […] Un B-movie western, realizzato però negli States. Certi temi, vedi il western, sono congeniti e appartengono alla memoria storica di una nazione. […] insopportabile sentimentalismo che inonda la pellicola, con la complicità della troppo lodata Claudia Cardinale. […] con Dario Argento tra gli sceneggiatori non si va lontano. […]” Il prologo è ridimensionato a “diciassette minuti di narcisismo registico”. Nemmeno Tonino Delli Colli si salva con i suoi “giochini grafici”. Perla conclusiva: “Un cult movie per ragionieri in vena di poesia”. “Verboso e filosofeggiante”, all’insegna di “un populismo spesso di maniera” Giù la testa secondo Mereghetti (anche se “le sequenze da antologia non mancano”). Insomma la critica, soprattutto da noi, non seppe, o non volle, capire. Impreparata al nuovo, scambiava i pregi per difetti. Leone se ne infischiava, la critica “arriva sempre in ritardo, salvo poi tornare sui propri giudizi, portando alle stelle lo stesso film che aveva distrutto” (cit. p. 261) La traversata del deserto occupò vent’anni, tanti ne occorsero prima che venisse riconosciuto come «autore». C’era una volta in America venne presentato a Cannes, fuori concorso: l’aver trovato accoglienza entro un importante festival internazionale era già il segnale di un’inversione di rotta. Il direttore Gilles Jacob aveva visionato il film nella versione integrale, restandone folgorato. Le recensioni – puntualmente documentate da Garofalo - furono entusiastiche e in Italia e fuori (con pochissime eccezioni, tra cui “Variety”, si parlò di nuovo Omero, di grande lezione di cinema, etc. Kezich anche approvò, evidenziando come il regista fosse riuscito a rendere sublime l’odioso, e scrisse parole che, rilette oggi, suonano profetiche: “Parlando di un’impresa così fuori misura bisogna citare gli associati: dall’operatore Tonino Delli Colli, allo scenografo Carlo Simi, dalla costumista Gabriella Pescucci, al montatore Nino Baragli e al musicista Ennio Morricone. Dire che sono bravi è poco, sono gli ultimi maestri di un sublime artigianato forse destinato a scomparire. Per i serials televisivi, girati in fretta e a buon prezzo, basta molto meno. Non a caso C’era una volta in America arriva in gran parte da Cinecittà, l’ultima vera fabbrica dei sogni dell’occidente” (8) (è arrivato il momento, e non da adesso, di togliere il “forse”). Tornando a quell’ieri che idealmente dista anni luce, si cominciò a capire, con effetto retroattivo a cascata, che le opere precedenti il Capolavoro – Il Colosso di Rodi compreso - non erano da buttare; si andarono a cercare – e si trovarono in abbondanza - i segni di un’autorialità in progress. Iniziarono a studiarlo, a scrivere di lui, a interpretare le sue opere che avevano conquistato le platee strizzando l’occhio agli intellettuali e ai cinefili: così, quasi senza farlo apposta, con narrazioni astute ovvero raccontando storie che erano riflessioni sui meccanismi stessi del narrare, insomma la “natura metacinematografica di tutto il cinema di Leone” come sintetizza Garofalo (p. 142). Gettiamo l’occhio sulla bibliografia riportata in appendice: escludendo gli interventi a caldo (recensioni su quotidiani e riviste), gli studi monografici iniziano dall’ultimo film. Con una rara aves, Oreste De Fornari che aveva a suo tempo pubblicato un lungimirante studio sul regista (Sergio Leone, Firenze, Moizzi, 1977).
La monografia in oggetto risale al 1999, la nuova edizione data 2020 e racconta ciò che è avvenuto nell’ultimo ventennio, celebrazioni, restauri delle pellicole addirittura un francobollo emesso da Poste Italiane nel 2019, trentennale dalla scomparsa. (Possiamo adesso aggiungere il bel documentario Sergio Leone. L’italiano che inventò l’America di Francesco Zippel, presentato alla settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia, che ricostruisce la biografia del cineasta attraverso le testimonianze di familiari, amici e collaboratori e che, idealmente unito a Ennio di Giuseppe Tornatore, origina un dittico di rara suggestione e intensità). Viene mantenuto l’impianto originario, una prima sezione per “la vita”, la seconda per “i film”. Nella prima i fatti, la famiglia, l’apprendistato, gli esordi, le vicissitudini legate alle singole pellicole; e i rapporti sempre difficoltosi con produttori e soprattutto distributori con annessi contenziosi legali avviati per lo più dal regista se si esclude la causa intentatagli dai giapponesi per avere «plagiato» Yojimbo nel primo western (sulla questione si può adesso con profitto leggere Dalla Katana al Revolver di Riccardo Rosati, Profondo rosso 2022). Rientra nella sezione informativa anche la preziosa crestomazia di giudizi critici all’uscita dei singoli film. Garofalo riporta molte dichiarazioni dello stesso Leone, ricavate dalle più svariate fonti (tra cui quel gioiello che è L’avventurosa storia del cinema italiano curata da Franca Faldini e Goffredo Fofi per la Cineteca di Bologna, Bibbia di testimonianze, il cinema raccontato da chi lo visse sul campo) e spesso da colloqui con l’autore con bell’effetto di presa diretta, al punto che non distingui tra la mediazione del critico e il racconto del regista. Ogni capitolo trae il titolo da una frase del maestro che condensa una frazione del suo vissuto-cinema in schegge memoriali (“In omaggio a mio padre mi sono ribattezzato Bob Robertson”, “Ero a Cinecittà per restare”) e sintesi spiazzanti (”Non ero affatto un patito di western”, “Io ho a disposizione una pistola e, qualche volta, un Winchester”, “Noodles non è mai uscito dal 1930”). A latere sta Leningrado, il “ciak in coda” che, grazie alle numerose dichiarazioni di Leone, riusciamo a tradurre in immagini da immaginare, in delizie da pregustare all’infinito in un desiderio che è ricordo di se stesso. I 900 giorni dell’assedio, in controcampo l’amore tra un reporter americano e una donna sovietica, l’intento di non voler fare cronaca storico-politica (“a me non interessa la cronaca ma la sua rielaborazione favolistica conciliata con il rispetto della verità”: cit. p. 293), le trattative laboriose con i russi giunte ad uno sbocco con Gorbaciov, tre ore di durata previste, De Niro interprete maschile quasi certo, la top model cecoslovacca Paolina Porizkova per il ruolo femminile, scenografie imponenti e migliaia di comparse, 2000 carri armati (la disponibilità era di 500, “gli altri li faremo di cartapesta”), la musica con la Sinfonia n. 7 Op. 60 –Leningradese- di Dmitrij Šostakovič e, naturalmente, Morricone (ma “delle musiche ancora non avevamo discusso […]. Era strano che non avessi già cominciato a elaborare qualche tema, ma ho sempre avuto la sensazione che Sergio sapesse che non sarebbe riuscito a finire quel progetto”) (9). Un altro sogno accarezzato dalla fine dei Sessanta, un altro itinerario impervio (in parte mitigato dal credito internazionale acquisito dopo l’ultimo film), il titanismo di un lottatore nato: “Non mi nascondo la difficoltà del compito, ma mi piacciono le imprese difficili, non vale la pena di misurarsi con film di routine” (cit. p. 298).
La seconda parte si concentra sulle singole pellicole, un capitolo per ciascuna e presenta un taglio meno narrativo, più ermeneutico. Le analisi sono precedute da accurate sinossi che ripercorrono gli snodi narrativi e consentono di «rivedere» e memorizzare l’oggetto dell’indagine.
La distinzione vita/film è di comodo, legata a esigenze strutturali. La vita di Sergio Leone fu il cinema in una simbiosi non romantico-estetizzante-decadente, essendo per lui il cinema l’apriori esistenziale, la settima arte il medium per dare corpo – visibilità - alle sue mitologie, ai suoi fantasmi di uomo – “Quando ho iniziato con i miei western ci ho messo tanti piccoli fantasmi personali”, cit. p. 174. - e di spettatore, homo videns moltiplicato che condensa nella sua opera una memoria letteraria e cinematografica vera almeno quanto quella della cosiddetta «vita reale»: “Uno dei primi amori europei della mia generazione è l’America del Mito. E’ l’America come ce l’hanno raccontata Fitzgerald, Dos Passos, Faulkner o mostrata Hollywood: l’epopea del West, il musical, il jazz, le imprese dei gangster interpretati da Cagney e Paul Muny, eccetera… tutto questo è diventato un fatto della nostra esistenza: queste gesta più o meno eroiche vissute da queste figure, da questi fantasmi, lasciavano un segno reale nel nostro modo di pensare e di vivere. Con C’era una volta in America ho voluto ritrovare proprio questo contatto giovanile […] (cit. p. 255). Qui veniamo al Mito, il cinema è Mito. Garofalo definisce Leone “regista mitologo”: ovvero colui che sul Mito lavora decostruendolo e ricreandolo. Il Mito americano e la sua fine; soprattutto, l’immaginario mitico creato dal cinema. I contenuti, i generi contano relativamente: regista scaltro, Leone sposta l’attenzione “dal significato al significante” (p. 103), dalla sostanza alla forma (alle forme) che la raffigura attraverso procedimenti sempre più sofisticati ed ambigui che lasciano largo spazio all’interpretazione spettatoriale: perché “in un film di serie B si dice ogni cosa ad ogni spettatore. In un vero film di serie A si lascia che il pubblico pensi” come disse Clint Eastwood al regista (cit. p. 103).
La prima tranche è una sorta di «enciclopedia Leone» e il racconto di una vita “condizionata dal cinema” (p. 15). Il padre Vincenzo (in arte Roberto Roberti), autore –“direttore artistico” o metteur en scène come allora si diceva (il termine regia sarà coniato nel 1932 dal linguista Bruno Migliorini e si affiancherà ai precedenti sintagmi sino a sostituirli; oggi si parla di «direttore artistico» solo più per il festival di San Remo) - di 51 film 15 dei quali con Francesca Bertini; la madre Edvige Valcareghi, spesso diretta dal marito come Bice Waleran (e si apre uno spaccato affascinante sull’epoca del muto e sui rapporti non sempre idilliaci tra cinema e regime come proprio Vincenzo Leone ebbe ad esperire); Mario Camerini (già assistente di Vincenzo) padrino di battesimo. Una benedizione, un’investitura. Il futuro regista si divide tra gli studi di giurisprudenza – che presto abbandonerà - e una proficua gavetta di assistenze, aiuto regie, regie di seconda unità, sempre con l’occhio acuto dell’apprendista stregone intento a rubare il mestiere dai bravi, a cogliere i limiti dai meno abili – e i secondi gli risulteranno più utili dei primi poiché da loro apprenderà gli errori da evitare -. Si fa le ossa con De Sica, Blasetti, Gallone, Soldati, Comencini, Steno e soprattutto Bonnard con otto film, del quale nei fatti dirige nel 1959 Gli ultimi giorni di Pompei in sostituzione del collega impegnato sul set di Gastone, al quale peraltro il film è attribuito nei crediti; ma anche Melvin Leroy, Robert Wise, William Wyler, Fred Zinnemann, Robert Aldrich. Garofalo ricostruisce puntigliosamente e sommerge il lettore sotto una messe di dati (sempre rigorosamente accertati) che lo immergono nel mondo cinema dai Quaranta ai primi Sessanta, dalle commedie ai peplum nostrani ai “polpettoni cristiano-imperiali” (come li definiva il regista) girati dagli americani fuori casa, nella “Hollywood sul Tevere”.
Leone esordisce ufficialmente con un film mitologico. Non che li amasse beninteso, odiava soprattutto i Maciste e rifiutò decine di proposte; poi, per ragioni alimentari e perché in quell’ambito bazzicava, fece nel 1961 Il colosso di Rodi cercando di metterci del suo: “all’interno del genere ha cercato di costruire un gioco nuovo, più dinamico, in cui spostare nel tempo e nello spazio un «eroe per caso» e invischiato in un complotto di derivazione hitchockiana: il riferimento esplicito che fa è proprio a Intrigo internazionale […]” (p. 83). Stiamo già de-generando (nella luce del dopo, potrebbe valere anche per Leone l’attributo di “terrorista dei generi” coniato da Paolo Albiero e Giacomo Cacciatore per Lucio Fulci?) (10). Da qui innanzi la biofilmografia del regista diviene il film dei suoi film con le lavorazioni tribolate e le defatiganti riprese, le spasmodiche ricerche degli interpreti, le lotte al coltello e gli eroici furori, le riunioni interminabili, i costi immani, le incomprensioni della critica e i deliri delle platee; sino alla consacrazione mondiale e al filo troppo presto reciso: tutto fuori misura, tutto consumato all’insegna dell’eccesso in un’esperienza di vita e di lavoro senza confronti. La rievocazione/visione di questo kolossal occupa 313 pagine su 537 e ci introduce al secondo viaggio, questa volta «dentro» il suo cinema. Garofalo utilizza strumenti formalistico/struttural/semiologici, individua i codici di ri-scrittura, inquadra i personaggi non come entità psicologiche bensì come funzioni del narrare, squarcia il velo delle suggestioni emozionali e figurative, mostra un retroterra celato all’occhio dello spettatore «ingenuo»; anche se poi il regista mirava a “creare la condizione primaria dello spettatore cinematografico” (p. 123). “Pensare di vedere il film da adulto, ma in realtà sedersi a guardarlo come un bambino” (cit. Ibidem).
Se la “vita” scorre nelle cadenze narrative, nella referenzialità opima e aneddotica, nella composizione di un «ritratto d’autore» plastico e verace; la seconda si avvale di un linguaggio critico robusto e a tratti tecnico, mette in opera una concettualità elaborata (e laboriosa per chi sta dall’altra parte) riflesso del pluristratificato cinema leoniano, la cui verità si nasconde dietro la bella menzogna di ammalianti “favole per adulti”. Ecco allora qualche assaggio, film dopo film:
Annientare il mito dall’interno appariva estremamente difficile: smontarlo come si può smontare un giocattolo, non perseguendo alcun effetto di realtà e senza particolari orpelli emotivi […] poteva essere invece la soluzione giusta per fare tabula rasa del genere «presto e bene», ovvero senza dissacrazioni, ma anche senza rimorsi. Dunque […], Il colosso di Rodi mette in evidenza i contorni dello scarto che produce tra sé e i film che lo hanno preceduto. La caratteristica di questo scarto, se non la sua natura, sta tutta in un diverso fine assegnato al proprio lavoro e al risultato di questo lavoro. Il «mondo antico» (e poi il West e l’America) di Leone, come la Parigi di Balzac, non riflette né una realtà né un’esperienza, ma, appunto, già un artificio. (pp. 341-342)
Ogni favola ama gli estremi, vive di polarità, di dualismo, manichee simmetrie. Per un pugno di dollari segue queste regole: fiabesco significa anche formalismo linguistico ed esattezza, nettezza d’esecuzione; insomma, realismo stilizzato, distacco geometrizzato da gesti reali, dialoghi scarni e spavaldi come da fumetto. (p. 356)
Per qualche dollaro in più è il film che meglio definisce la bipartizione ambigua dei personaggi leoniani tra coloro che agiscono per una causa e coloro che sono mossi dal profitto. […] il cinema, come la lingua, è una forma e non può essere realista o irrealista. La fortuna del cinema di Leone, che ne ha garantito una specie di inossidabilità resistente al tempo, sta anche nel fatto che Leone ha sempre evitato di confondere il reale ideologico con quello semiologico. (p. 377)
Le «ossessioni d’autore» restano le stesse anche nel capitolo conclusivo della prima trilogia: il desiderio e l’impossibilità di credere al sogno americano dello spazio di conquista, il crollo dell’individuo che non si riconosce più nell’insensatezza del mondo, un utilitarismo anarchico di fondo come reazione. […] il film più scatenato e ipercinetico di Leone e, forse, il più amaro e sprezzante, con Giù la testa, nella rappresentazione della violenza. […] giunti a questo livello di profondità icastica (due occhi che riempiono completamente lo schermo) lo zenit dello specifico western è raggiunto: non è possibile andare oltre, se non retrospettivamente, non a caso, con un titolo che recita C’era una volta il West. (pp. 395, 400, 408)
C’era una volta il West è il racconto di una separazione, quella tra il mito e il contesto socioeconomico attraverso il quale lo stesso mito è sorto, uno studio di cinema distinto dalla storia, alla fine da questa distrutto. Un discorso che in chiave di parodia sarà poi il soggetto di Il mio nome è Nessuno. […] Il problema riguarda la «fine» della storia e correlativamente il ruolo del «futuro» come attesa, un problema che è al centro degli ultimi due capitoli della seconda trilogia. (p. 428)
In Giù la testa egli fa uso di un cartello che non si sovrappone alle immagini ma che le precede. E’ un appello allo spettatore, quasi temesse che chi guarda rischi di non individuare la chiave di lettura «artificiale» e vada quindi a cercare quel realismo che nel film non può essere trovato. (p. 443)
C’era una volta in America ci ha mostrato il cinema non più come luogo dello spettacolo, ma spettacolo del luogo […]. Per questo è un film d’una maturità intellettuale e di una maestria tecnica esemplare. […] E’ il ritratto frantumato di un mito che parla di distruzioni e future ricomposizioni, della «verità vera» di Leone «più falsa del falso», una storia irreale che ha narrato di sogni inquieti, di cinema come rifrazione del mondo e sua interpretazione, è forse la nostra storia, fatta di memorie e premonizioni, proiettata nel buio di una piccola sala con le sedie di legno. (p. 481)
Non proprio facile come si vede. Un libro per pochi allora, una élite di addetti ai lavori, di iniziati, di intellettuali? Ma no. Un libro per chi ama il cinema e non solo quello del regista romano le cui opere di cinema sono ipernutrite (merito di Garofalo precisare i referenti, gli omaggi e le prese di distanza). Un lavoro ad ampio spettro che aiuta a comprendere, almeno a intuire gli innumerevoli sottotraccia di un autore che si mascherò sotto le forme seducenti – ed ingannevoli - dello spettacolo «popolare», “sofisticato senza essere elitario, complesso senza essere oscuro” (p. 8), e che per questo gli spettatori amarono anche negli esiti più stilizzati. Chiamare «popolare» C’era una volta in America suona bestemmia; ma il film incassò, in Italia, 3.102.457.000 solo nelle dodici città capozona. E negli States fu un fiasco la versione sforbiciata e ricomposta in ordine cronologico, un trionfo quella pensata dal regista pur con tutte le ambiguità, i salti temporali, la struttura non lineare. Il pubblico non è poi così stupido, può snobbare i film «impegnati» (come li chiamavano ai tempi dei tempi), cerebrali, freddi; ma Leone «colpiva al cuore» (al cuore, Ramon), arrivava a tutti con la forza di quelle immagini, l’arguzia di quei dialoghi, il sentimento del tempo e la nostalgia senza languori. E piaceva ai giovani. Proprio il secondo c’era una volta fu venerato dal pubblico giovanile: “Quello che più mi ha gratificato, e che non mi aspettavo, perlomeno in questa misura, è stato l’entusiasmo dei giovani. Mentre giravo il film pensavo che venisse amato e capito fino in fondo dagli uomini della mia generazione e costoro lo hanno amato e apprezzato, ma chi lo ha idolatrato fino a vederlo sei, sette volte, è stato il pubblico giovanile, quel pubblico che in fin dei conti diserta Dallas, Sentieri, e tutte quelle telenovelas che ci propinano in televisione ed è sempre più alla ricerca del cinema e di un cinema vero” (cit. p. 255). Una delle tante dichiarazioni del regista, che affollano il libro e gli conferiscono quel sapore di verità che altrimenti mancherebbe, le sue idee sul cinema, sul tempo e la memoria, sulla televisione per la quale ha parole sferzanti perché produce un cinema “modellato sulla pubblicità” ma della quale intuisce la possibile funzione di “pubblica biblioteca”, archivio del cinema che fu per conoscerne la storia (peccava di ottimismo, lui così filosoficamente pessimista: conosciamo il livello e l’arco temporale dell’offerta cinematografica delle varie televisioni, le poche deroghe – vedi Rai Storia - illuminano ancor più i panni sporchi dell’indecenza).
Monografia, saggio, ed anche repertorio. Il volume si correda di appendici preziose che fungono da preliminare banca dati. Innanzitutto una filmografia completa con regie, produzioni, coproduzioni e contributi tecnico-organizzativi, soggetti e sceneggiature, aiuto regie, spot pubblicitari. Le schede dei film si segnalano per esaustività, sono indicati anche i fonici e i capomacchinisti ed elettricisti, i doppiatori, per la musica i solisti e gli editori musicali. Si preserva dall’oblio un mondo scomparso di operose maestranze, d’alta bottega. I meno giovani assaporeranno le delizie dei cataloghi onomastici: quei nomi talora strani, esotici quasi, che si fissavano nella mente alimentando fantasie ed oggi restituiscono il flavour di “un certo tipo di cinema maiuscolo” (p. 12). Poi la bibliografia, folta e ragionata: opere di carattere generale, scritti del regista, interviste, monografie, volumi dedicati ai singoli film, studi collettivi e numeri speciali, una selezione di saggi e articoli, testimonianze, documentari. I progetti non realizzati? Ci sono anche loro, sparsi lungo il testo e fonte di sorprese: il remake di Via col vento, la trasposizione di Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline, un kolossal tv su Gengis Khan, uno stuzzicante Vado, l’ammazzo e torno sul regicidio di Monza ad opera dell’anarchico Gaetano Bresci, ed altro, stupefacente videoteca virtuale firmata Sergio Leone.
Marcello Garofalo è presentato in terza di copertina come critico cinematografico, regista, saggista, curatore di mostre, collaboratore di “Ciak” e presente nel comitato di redazione di “Segnocinema”: curriculum adeguato per affrontare il ponderoso soggetto. Ne è uscito un contributo che ci appare, nel suo fondere ricostruzione e interpretazione, fondamentale nel panorama di studi sul regista, obbligatorio per quanti incontrarono Leone negli anni della prima immaginativa e subito lo amarono.
(1) LORENZO PELLIZZARI, La troppo lunga notte del western all’italiana, in “cinema Nuovo”, n. 185, gennaio-febbraio 1967, p. 18.
(2) Per Grazzini, citiamo a memoria da un vecchio Catalogo Bolaffi del cinema italiano. Kezich in Id., Il Millefilm, Milano, Mondadori, 1983, pp. 120-121.
(3) UMBERTO ROSSI, E’ già iniziata la resa dei conti? In “Civiltà dell’immagine”, n. 4, agosto 1967.
(4) Bianco e Nero, n. 11-12, novembre-dicembre 1964, pp. 113-115.
(5) Un superuomo per miliardi di dollari in “Cinema Nuovo”, n. 173, gennaio-febbraio 1965, p. 19.
(6) Qui anche si cita a memoria da “La Domenica del Corriere”.
(7) MARIO SOLDATI, Nascita del western italiano, in Da spettatore, Milano, Mondadori, 1973, pp. 179-184 (originariamente in “L’Europeo”, 28 novembre 1964).
(8) “La Repubblica”, 22 maggio 1984.
(9) ENNIO MORRICONE, Inseguendo quel suono, Milano, Mondadori, 2016, p. 109.
(10) PAOLO ALBIERO-GIACOMO CACCIATORE, Il terrorista dei generi. Tutto il cinema di Lucio Fulci, Palermo, Edizioni LEIMA, seconda edizione aggiornata, 2015.