16 Mar2014
Grand Piano
 Victor Reyes
Victor ReyesIl ricatto (Grand Piano, 2013)
MovieScore Media/Kronos Records MMS14010/KRONCD045
5 brani – durata: 32’22”
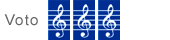
Diamo qui per sufficientemente nota la “teoria dei livelli” di Sergio Miceli. Quella cioè che distingue il livello interno di una musica cinematografica (quando la stessa è prodotta da qualcosa di contestuale al racconto: una radio, uno strumento, un’orchestra in scena); il livello esterno (quando la musica è in funzione di accompagnamento non “realistico”, cioè non suffragata da fonti dirette); e il livello mediato (quando una presenza musicale nasce come livello interno e diviene progressivamente livello esterno: esempio conclamato, il tema dell’Armonica di Morricone in C’era una volta il West).
L’opzione su quale di questi livelli adottare dev’essersi posta imperiosamente al regista Eugenio Mira e al compositore spagnolo Victor Reyes (di cui ricordiamo la claustrofobica, fenomenale partitura per Buried) alle prese con questo thriller musicale interamente ruotante attorno all’esecuzione di un pezzo, “La Cinquette”, il cui virtuosismo trascendentale è anche il passaporto per la vita o la morte del protagonista, il pianista Tom Selznick (Eljiah Wood), gravato da un fiasco nel proprio passato, perseguitato da attacchi di panico e minacciato, tenuto letteralmente nel mirino da un killer se non eseguirà alla perfezione proprio quel brano. Al netto delle referenze hitchcockiane nel nesso tra musica classica e suspense (valga per tutti L’uomo che sapeva troppo ma, più in chiave psicologica, citeremmo anche La voltapagine di Denis Dercourt e Quattro minuti di Chris Kraus, entrambi del 2006, oltre al vecchio, indimenticabile e nerissimo Nelle tenebre della metropoli di John Brahm, 1945, con il leggendario “Concerto Macabre” di Bernard Herrmann), è evidente come le scelte musicali in un contesto narrativo simile condizionino con forza la struttura drammaturgica stessa del film e pongano, al regista ma soprattutto al compositore, problemi enormi. Con il fattore musicale elevato a protagonista assoluto, infatti, si aprono solo due possibili strade: adottare uno degli infiniti pezzi di repertorio esistenti nella letteratura per pianoforte e orchestra, o comporre musica originale. La scelta è andata in questa seconda, sicuramente più impegnativa, direzione, poiché evidentemente serviva agli autori una partitura da poter modellare sugli eventi, anziché il contrario, pur con le caratteristiche stilistiche del concertismo classico. La risultante è uno score diviso in tre parti: i Main Titles, la sezione concertistica e appunto “La Cinquette”: il tutto per un impianto esecutivo classico, ovviamente tradizionale, che impegna la City of Prague Philharmonic Orchestra sotto la bacchetta attenta di Adam Klemens e con il contributo di ben due solisti alla tastiera, lo stesso Reyes e John Lenehan.
Il risultato è multiforme e oltremodo interessante: i Main Titles appaiono come il vero corpo estraneo, ossia il marcatore di distanza tra i livelli narrativi: è un brano di suoni quasi meccanici, di fabbrica, volutamente “alieni” ed estranei al contesto, e per ciò stesso leggibili come livello “esterno”.
Poi c’è il “Grand Piano Concerto” diviso in tre movimenti. Appare immediatamente chiaro che la scrittura pianistica di Reyes guarda ai grandi modelli tardo romantici dello strumento: non solo Ciaikovski, il cui Concerto n.1 è dichiaratamente citato nel Primo Movimento, ma anche Liszt e Rachmaninov, di cui Reyes recupera il virtuosismo infuocato, le cascate sonore, gli squarci lirici e gli improvvisi incupimenti drammatici. Il secondo movimento è in particolare un fuoco d’artificio di scale, sovrapposizioni, accordi ribattuti, acrobazie virtuosistiche in cui orchestra e piano duellano più che dialogare, secondo moduli compositivi non scevri da qualche banalità tonitruante. Più veloce, breve e icastico il terzo movimento, che sembra in qualche modo preparare al brano-clou, “La Cinquette”.
Qui ci troviamo dinanzi ad un pianismo “barbaro”, memore dei giovani Bartòk e Prokofiev: lo strumento è solo, come solo è il protagonista che ha sulla punta delle proprie dita il proprio destino. La pagina ha, a differenza dell’ottocentismo fluente e torrenziale del “Grand Piano Concerto”, caratteristiche nettamente novecentesche: l’incipit non è estraneo addirittura a influssi di John Cage, la scrittura è spigolosa anche nella prima parte lenta, la mano sinistra è chiamata ad un ruolo percussivo, come nel pianismo degli autori sopra citati. Il caos organizzato che si scatena nella seconda parte ha come punti di riferimento il Secondo Concerto di Bartok e il Terzo di Prokofiev e s’infiamma di una destrezza esecutiva demoniaca, soffocante e ansiogena, bruscamente troncata in una lunga pausa cui segue la nota grave conclusiva.
“Pièce” di bravura dunque, in ogni senso (filmico e musicale), e spericolata sfida compositiva su un terreno minato da precedenti illustri e da referenzialità classiche incombenti. Se c’era un’altra via per uscirne, va detto che compositore e regista hanno sicuramente scelto la più ardua.