28 Gen2015
Exodus: Gods and Kings
 Alberto Iglesias, Harry Gregson-Williams, Federico Jusid
Alberto Iglesias, Harry Gregson-Williams, Federico JusidExodus – Dei e re (Exodus: Gods and Kings, 2014)
Sony Classical 501908
32 brani – Durata: 78’01”
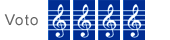
L'andamento ondivago della musica nella filmografia di Ridley Scott rivela una verità di fondo: il cineasta britannico è scarsamente interessato a questo aspetto, di cui gli interessa una funzionalità meramente descrittiva e scenografica, assai più di una qualche coerenza stilistica o linguistica (paradossalmente il mai abbastanza rimpianto fratello Tony era assai più attento a questo elemento); rientra in questo metodo, crediamo, anche la fidelizzazione con la Zimmer-Factory, che ha prodotto risultati maiuscoli nei casi in cui è stato coinvolto direttamente il caposcuola (Black Rain, Hannibal, Il gladiatore) , un po' meno quando sono stati chiamati in causa gregari come Gregson-Williams o Streitenfeld.
Ora alla bisogna è stato paracadutato dall'universo almodovariano il valoroso Iglesias, che forse di tutta la scuola spagnola è la figura più esperta sul piano internazionale, quantunque affiancato in alcune pagine cruciali di additional music dal fidato Gregson-Williams e dal quarantenne argentino Federico Jusid, già distintosi per lo score di Il segreto dei suoi occhi (2009, di Juan Josè Campanella).
La partitura di Exodus si propone immediatamente come un maestoso, verticale affresco sinfonico-corale di proporzioni amplissime, saldamente ancorato ad un paio di temi suggestivi e imponenti (soprattutto il vigoroso tema di Mosè), nel quale però al posto del titanismo strutturale zimmeriano o parazimmeriano spicca un pathos di travolgente emotività, un impeto neoromantico vibrante e fortemente comunicativo. Concorrono a questo esito diversi fattori: prima di tutto l’utilizzo diffuso ed evocativo sia di strumenti etnici caratteristici dell’area mediorientale che delle voci umane, tanto corali quanto solistiche, con una spiccata propensione verso il vocalizzare arabo (“Opening – War room”, “Moses in Pyfhon”) il che colloca immediatamente la partitura in un preciso contesto culturale; poi il ricorso frequente al coro misto in funzione squisitamente strumentale, con una sillabazione violenta e martellante, quasi percussiva, che rimanda a precisi precedenti goldsmithiani o williamsiani, come in “The Coronation” o nella breve, rabbiosa “Ramses retaliates”, entrambe tracks composte da Jusid. Altro elemento forte dello score è la musica di pura battaglia, alla quale è di preferenza preposto Gregson-Williams; “Hittite battle” è ad esempio pagina di intricatissima architettura, dove convergono suoni tipici delle latitudini mediorientali in una ritmica sobbalzante e stringente; analogo discorso vale per “Tsunami”, concepito secondo una progressione epico-corale travolgente, caratteristica del compositore inglese.
Certo, al di là dei due temi portanti, che salgono d’intensità e di presenza verso l’epilogo, si fa un po’ di fatica ad orientarsi lungo una traccia leitmotivica; quando accade però, ne vale la pena, come nel canto toccante del cello e poi dei violini che si alza da “Goodbyes”. In compenso, memori forse di alcuni precedenti zimmeriani (soprattutto nel Gladiatore), compaiono citazioni wagneriane pressoché letterali, come nel caso delle prime battute del “Rheingold” riproposte nei larghi arpeggi sull’accordo in mi maggiore di “I need a general”, mentre sottili e penetranti variazioni sul tema di Mosè si intrecciano in “Lamb’s blood”, ancora di Jusid. A Iglesias competono però gli aspetti forse meno convenzionali e più interessanti dello score, come “Ramses’ insomnia”, minacciosamente oscuro nel viluppo degli archi, o il lamento struggente di “Climbing Mt. Sinai” o ancora le complesse evoluzioni degli archi solisti di “Alone in the desert”, dove ciascuno strumento assume le caratteristiche della voce umana in una ricerca costante del puro mèlos. Alla lunga sembra allora di intuire che la ripartizione del lavoro sia avvenuta più o meno assegnando a Gregson-Williams e Jusid le pagine più epiche, “colossali” e d’azione (e “The Chariots”, di quest’ultimo, ne è la ribollente riprova), mentre Iglesias ha provveduto al lato più intimo, doloroso, raccolto delle atmosfere, confermando una classe sovrana che pare quasi sciogliersi nell’abbraccio finale di “The Ten Commandments”, al tempo stesso straordinariamente arioso e sommamente concentrato. Il che fa del compositore di San Sebastián, come già accennato, la figura forse più cosmopolita – insieme a Fernando Velazquez – nella musica per film iberica degli ultimi anni.