Loveless
 Evgueni e Sacha Galperine
Evgueni e Sacha Galperine
Loveless (Nelyubov, 2017)
Varese Sarabande 302 067 522 8
9 brani – Durata: 29’46”
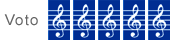
Sin dai tempi dell’ex-Urss, anzi addirittura a partire dall’epoca immediatamente postrivoluzionaria, la musica per film russa è sempre stata un passo avanti a qualunque altra scuola nazionale, sia in termini di ricerca formale che di intima adesione ai tormenti e alle inquietudini di quella immensa cinematografia. Non si è trattato solo di Prokofiev e Shostakovich, i due casi più eclatanti, ma di intere generazioni di compositori formatisi nella convinzione di un primato del cinema come linguaggio artistico e strumento pedagogico. Anche quando ciò ha assunto i contorni della più sfacciata propaganda, come durante l’era del terrore staliniano, del “realismo socialista” e dei famigerati “rapporti Zdanov”, musicisti come Andrej Petrov o Tikon Krennikov si sono fatti carico della retorica nazionalista e ideologica con una grandiosità quasi religiosa, appellandosi alla grande tradizione popolare dell’Ottocento.
In seguito, col disgelo, la perestrojka, il dissolvimento dello stato sovietico e più recentemente l’egemonia di Putin, i musicisti si sono sentiti liberi di perseguire ciascuno le proprie ispirazioni, che però sembrano confluire – quantunque da personalità diverse – verso un comune denominatore di rarefazione, prosciugamento espressivo, a tratti macabra ironia o coltissimo citazionismo: sono brillati così dapprima Vyacheslav Ovchinnikov, pure ancora legato a canoni kolossalistici, e poi Eduard Artemyev, il compositore di Andrej Tarkovskji, e più di recente Andrej Sigle, il musicista di Aleksandr Sokurov, e Andrej Dergatchev per il cinema di Andrej Zvyagintsev.
Proprio a quest’ultimo regista, scabro e rigoroso narratore di storie di solitudine e desolazione sentimentale, vincitore del Leone d’oro a Venezia nel 2003 con Il ritorno, è associata la partitura di due figure iscrivibili alla nuova generazione, quella dei quarantenni, di compositori russi per il grande schermo, i fratelli Evguenj e Sacha Galperine. Formatisi in patria ma attivi soprattutto in Francia, dove hanno collaborato con registi come Jacques Audiard, Jean-Baptiste Leonetti e Luc Besson (Cose nostre – Malavita), i Galperine si muovono in un complesso universo elettro-acustico nel quale scavano a fondo alla ricerca non del “bel suono” o della facile melodia ma bensì di un tessuto espressivo aspro, inospitale, ottenuto con mezzi spesso ridotti all’osso attraverso un camerismo estremo e non immemore delle avanguardie del secondo Novecento. Il clima sonoro ideale per il nuovo film di Zvyagintsev, angosciosa e potente storia di “disamore” (questo sarebbe il titolo esatto) e di una sparizione in una famiglia borghese nella confusa Russia di oggi: in un’economia strumentale essiccata, che ricorda quasi l’ultimo Shostakovich, i Galperine inseguono un suono materico, di brutale semplicità, evocando un deserto dei sentimenti con insistenti pizzicati degli archi intrecciati a spente note del pianoforte (“Drops and iron nails”), oppure inchiodandosi ad un ossessivo ritmo ribattuto di accordi pianistici, ottoni e percussione nel lungo “11 cycles of E”, quasi a scandire un invisibile cronometro mentale secondo un’articolazione ben definita nel titolo (undici cicli di accordi in mi ripetuti). Si tratta, con tutta evidenza, di una musica di ricerca che punta a restituire il vuoto devastante di affetti in cui orbitano i protagonisti,: un risultato ottenuto attraverso la sottrazione di mezzi e l’inasprimento dei colori timbrici. L’accordo freddo, respingente, di “Trouble” si trasforma così in uno straziante adagio per archi costruito per brevi, faticose frasi politonali di “The search”, mentre “Snowstorm” è pensato con un processo di accumulo di suoni elettronici, in un’atmosfera misteriosa e sfuggente che finisce con lo svuotarsi lentamente verso il nulla. Dal nulla paiono provenire anche i pizzicati secchi, senza vibrato, legnosi di “The cry”, intersecati da flebili tentativi di accenni pianistici, in un paesaggio complessivo dove il silenzio stesso si fa suono, presenza, minaccia.
In “Alyosha” subentra anche, come altrove, la voce umana ma non certo in veste di canto bensì di grido, lamento o – alla fine di “The toy train” – chiocciare di bambini: tuttavia anche qui è l’immobilità orizzontale di fasce sonore, “cluster” ostili e brontolanti formati da sovrapposizioni e provenienze le più diverse, a prevalere. Forse “The song” è il brano più lineare e leggibile, affidato al quartetto d’archi secondo la forma di un nuovo adagio quasi ciaikovskiano: ma si tratta di un melodismo catafratto, distanziante, in cui gli strumenti suonano freddi, strascicati, secondo percorsi armonici destabilizzati e funerei. Perché l’approdo finale, ancora e sempre, è quello di un profondo smarrimento interiore, di una musica che si inabissa compostamente e inesorabilmente nel gelo profondo di un paesaggio che è psicologico prima ancora che geografico.